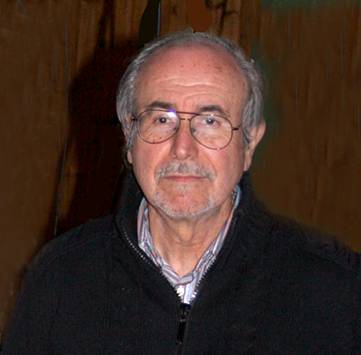
Spettroscopia
Spectroscopy
Fulvio Mete- Roma
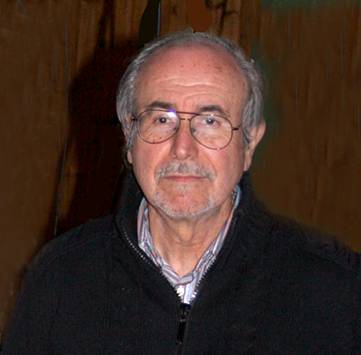
siti web :
http://www.lightfrominfinity.org
23 marzo 2017
E’ disponibile on line il mio testo in materia di spettroscopia
astronomica amatoriale.
Mi sono impegnato in questa non facile impresa non certo per questioni
economiche, in quanto il libro è gratis, ma per la volontà decisa di allargare
quanto più possibile la platea degli interessati a questa fondamentale branca
dell’astronomia.
In tale ottica, le due caratteristiche fondamentali del mio lavoro sono
le seguenti:
- La
divulgazione delle mie esperienze in spettroscopia; questo è quindi un libro nel
quale io racconto in modo limitato le esperienze altrui, focalizzando
l’attenzione del lettore sulle esperienze pratiche e teoriche del mio lavoro
degli ultimi vent’anni.
- La
finalità di essere quanto più possibile , in una materia difficile,chiaro e
colloquiale, nel preciso intento di attrarre e non respingere; quindi anche le
formule sono corredate da esempi alla portata di chiunque abbia un diploma di
scuola media.
Il testo conta 377 pagine formato A4 ed è il primo in Italia nella
lunga storia dell’astronomia amatoriale in questo paese, e, quel che più conta,
è scritto da un amatore per gli astronomi amatori. Come molti sanno, il mio
curriculum universitario è di Scienze economiche, ma in un lontano passato il
caso ha voluto che un professore di matematica di Ingegneria a Napoli insegnasse
anche la sua disciplina nella mia facoltà di Economia, con la conseguenza che il
programma di analisi matematica era identico nelle due facoltà, e molto
pesante.All’epoca ho pianto lacrime amare su tale scelta accademica, ed ho
sacramentato non poco per la difficoltà di uno studio particolarmente
complesso.In seguito poi ho ringraziato mentalmente coloro che avevano fatto
tale scelta, per le possibilità che la scelta stessa mi aveva fornito,
specie nel campo dell’astronomia che ho praticato da amatore, ed in quello della
spettroscopia, per la migliore comprensione della sua parte matematica.
Nei link sottoindicati potranno essere scaricati il libro on line in
formato PDF e,per chi volesse stamparlo, la relativa copertina.Il testo è per
uso personale e non è consentito in nessun caso cederlo a terzi, a titolo
gratuito o a pagamento: eventuali eccezioni e casi particolari dovranno recare
il consenso esplicito dell’autore.
Link del
Libro Cenni
di spettroscopia amatoriale .pdf
Link
della copertina copertina.jpg
Link
della pagina Facebook : https://www.facebook.com/Fulvio-Mete-Lightfrominfinity-193295981096944/

Lorenzo Franco - Roma
Appassionato di astronomia da sempre tanto da intraprendere un corso
di studi a carattere scientifico, laureandosi in Astronomia all'università di
Bologna, Lorenzo Franco conduce le sue osservazioni da Roma (Balzaretto
Observatory, codice MPC: A81). I principali campi di interesse sono
l'astrometria, la fotometria e la spettroscopia. Ha all'attivo più di 60
pubblicazioni scientifiche come autore/coautore ed oltre 20 articoli
divulgativi. Ha concorso alla scoperta di quattro asteroidi binari e venti
stelle variabili.
L'elenco aggiornato delle sue pubblicazioni si trova al link:
http://digilander.libero.it/A81_Observatory/70/index.html
Un interessante lavoro di Lorenzo Franco sulle applicazioni di spettroscopia amatoriale presentato al convegno di Faenza degli Astrofili ricercatori:
Fulvio Mete- Roma
15 aprile 2017
Esperimento di Young sulla doppia fenditura con uno spettrografo
Young double slit experiment by a spectrograph
Noi appassionati di spettroscopia siamo ormai abituati a convivere con due fenomeni fondamentali della luce : l'interferenza e la diffrazione, entrambi spiegabili soltanto considerando la natura ondulatoria della luce e dei fotoni.Ma la discussione sulla natura della luce viene da molto lontano,e precisamente dalla fine del 17° secolo, allorquando lo scienziato olandese C. Huygens propugnò la teoria ondulatoria , in opposizione a quella particellare, fatta risalire a Newton, secondo la quale la luce sarebbe stata composta da particelle in moto che obbedirebbero alle leggi della meccanica.Molto tempo dopo, fu lo scienziato inglese Thomas Young a dimostrare in modo inconfutabile la natura ondulatoria della luce con un esperimento che ha fatto storia.Tale esperimento è geniale perchè assolutamente semplice ed alla portata (oggi ) di tutti coloro che vogliano effettuarlo: il passaggio della luce di una sorgente che la emette raggi luminosi della stessa frequenza ed in fase tra loro attraverso un interferometro del tipo più semplice che possa esistere: una fenditura seguita da due fenditure di piccola apertura e molto ravvicinate (1/4-1/5 mm) .L'esperimento in questione fu successivamente ripetuto dal fisico francese Augustine J. Fresnel che fece l'analisi matematica e l'interpretazione dei risultati dell'esperimento di Young, oltre a ripeterlo per proprio conto.Sembrava allora certo che la luce ed i fotoni avessero natura ondulatoria, ma altri fenomeni, come l'effetto fotoelettrico sembravano dare per certo l'opposto, ovvero la natura corpuscolare dei fotoni e delle altre particelle.Il dualismo onda - particella e la sovrapposizione di stati ha permeato e caratterizzato da allora la fisica moderna, ma questa è un'altra storia.Tornando all'esperimento di Young, la logica di questo era estremamente semplice:
Colpendo una lastrina con
due fenditure sottili con i fotoni di un raggio luminoso monocromatico e
coerente , ci aspetteremmo di vedere in uno schermo posteriore in corrispondenza delle due aperture
i fotoni stessi raggrupparsi in due strisce luminose: l’aspetto corpuscolare sarebbe confermato
We amateur
spectroscopist are now accustomed to living with two fundamental phenomena of
light: interference and diffraction, both of which can only be explained by the
wave nature of light and photons. But the discussion on the nature of light
comes from far away, and precisely From the end of the 17th century, when Dutch
scientist C. Huygens advocated the wave theory, as opposed to the particle one,
which was traced back to Newton, according to which light would be composed of
particles in motion that would obey the laws of mechanics. Later on, was the
English scientist Thomas Young to unmistakably demonstrate the wave nature of
light with an experiment that has made history. This experiment is brilliant
because it is absolutely simple and the reach (today) of all those who want to
do it: the passage of Light of a source that emits luminous beams of the same
frequency and in phase between them through an interferometer of the simplest
type that may exist: a slit followed by two slits of small aperture and
very close (1 / 4-1 / 5 mm) to each other. The experiment in question was
repeated by French physicist Augustine J. Fresnel He did the math analysis and
the interpretation of Young's experiment results, as well as repeating it for
himself. It seemed then that the light and the photons had an wave nature, but
other phenomena such as the photoelectric effect seemed to give the opposite, or
the corpusculous nature of the photons and other particles. The dual
wave-particle and the superimposition of states has permeated and characterized
modern physics since then, but this is another story. Turning to Young's
experiment, the logic of this was extremely simple:
By striking a sheet with
two thin slits with the photons of a monochromatic and coherent light ray, we
would expect to see in the rear screen at the two apertures the photons
themselves clustered in two bright strips: the corpuscular appearance would be
confirmed.
Invece nella realtà vedremo formarsi nella lastra bersaglio un alternarsi di frange chiare e scure con un massimo centrale,una figura dovuta all’interferenza dei fotoni tra di loro.
Instead, in reality, we will see in the target plate an alternation of light and dark fringes with a central maximum, a figure due to the interference of the photons between them.
In effetti la figura di diffrazione conseguente all'interferenza delle due onde in uscita dalla doppia fenditura ha un aspetto complesso, con un massimo centrale, due massimi di minore intensità ed altri ancor meno intensi, come si osserva con maggior dettaglio nella figura che segue.
In fact, the diffraction pattern due to the interference of the two waves outgoing from the double slit has a complex appearance, with a central maximum, two lower intensity and some less intense, as can be seen in greater detail in the figure below.
Fin qui l'esperimento originario di Thomas Young, l'interferenza tra le due onde in uscita provoca l'immagine di diffrazione che si osserva nella figura precedente, a dimostrazione della natura ondulatoria dei fotoni e della luce.Ma questo è solo un aspetto della questione, che porta molto più lontano.Oggi i ricercatori sono in grado di inviare singoli fotoni,uno alla volta ed in modo assolutamente casuale , sulle due fenditure dell'esperimento: alcuni di essi passano attraverso la prima fenditura, altri attraverso la seconda, altri ancora tra nessuna delle due.Ogni fotone è quindi indipendente, sia spazialmente che temporalmente, dagli altri.In tali condizioni , quindi, essi non hanno alcun modo di interferire tra loro, e ci si aspetterebbe di osservare, dopo un certo periodo di tempo, un'immagine simile a quella della prima delle figure soprastanti: invece, meraviglia! il risultato di questo secondo esperimento è del tutto simile a quello originario di Young,il singolo fotone, che è una particella, si comporta come un'onda: cosa inspiegabile con la meccanica classica, ma spiegata dalla meccanica quantistica.In un simile stato di cose, l'unica certezza è la partenza e l'arrivo di un fotone sullo schermo, tutto quello che succede tra la partenza e l'arrivo è regolato da leggi probabilistiche: ciascun fotone ha quindi uguale probabilità di passare tra la prima o la seconda fenditura, o (per quanto sembri strano) attraverso entrambe, interferendo con sè stesso! Mentre in meccanica classica dati due stati possibili ( passaggio attraverso una fenditura o l'altra) il verificarsi dell'uno esclude quello dell'altro, in meccanica quantistica si può avere anche uno stato che sia una combinazione lineare degli altri due (nel caso il passaggio della singola particella attraverso le due fenditure) e, in generale, un sistema di "sovrapposizione di stati" nel quale tutti gli stati possibili coesistono (ed addirittura, come visto, possono interferire l'uno con l'altro) sino al momento in cui viene effettuata una misurazione: non abbiamo la possibilità di osservare fotoni od altre particelle in sovrapposizione di tutti gli stati possibili, ma solo nello stato corrispondente a quello in cui viene osservato.Sussiste inoltre una funzione d'onda e l'impossibilità di determinare contemporaneamente posizione ed impulso, ovvero realtà oggettiva a queste due grandezze fisiche (Principio di indeterminazione di Heisemberg).
So far Thomas Young's original experiment, the interference between the two outgoing waves causes the diffraction image to be seen in the previous figure, demonstrating the wave's nature of the photons and light. But this is just one aspect of a matter that brings much further away. Today, researchers are able to send individual photons, one at a time and in a totally random way, on the two slits of the experiment: some of them pass through the first slit, others through the second,others still in none of the two. Each photon is therefore independent, both spatially and temporally, from the others. Under these conditions, therefore, they have no way of interfering with each other, and one would expect to observe, after a certain period of time, an image on the screen similar to that of the first of the above figures: instead, wonder! The result of this second experiment is quite similar to that of Young, the single photon, which is a particle, behaves like a wave: something unexplainable with classical mechanics, but explained by quantum mechanics. In such a state of things, the only certainty is the start and arrival of a photon on the screen, all that happens between the start and the end is governed by probabilistic laws: each photon therefore has the same chance of switching between the first or the second slit, or (as it looks strange) through both, interfering with itself! While in classical mechanical theory in two possible states (passing through a slit or another) occurrence of one excludes one from the other, quantum mechanics may also have a state that is a linear combination of the other two (in the case of The passage of the single particle through the two slits) and, in general, a "superposition of states" system in which all possible states coexist (and even as seen may interfere with each other) until the moment For which a measurement is made: we do not have the possibility to observe photons or other particles overlapping all possible states, but only in the state corresponding to the one in which it is observed. There is also a wave function and the impossibility of determining simultaneously Position and impulse, that is, objective reality to these two physical quantities (Heisemberg's principle of indetermination).
Senza alcuna intenzione di voler disturbare la fisica quantistica, ho voluto qualche giorno fa tentare il classico esperimento di Young della doppia fenditura su uno dei miei spettrografi solari,HIRSS2 utilizzando appunto la luce solare, che, come si sa, è policromatica ed incoerente. Ho quindi acquistato un piastrina alluminata con sopra una serie di tre doppie fenditure di 70 micron distanziate rispettivamente 200, 300 e 500 micron, che ho inserito in un supporto a coda di rondine per centrare alternativamente la fenditura di interesse.La piastrina è in vendita da alcuni distributori di strumenti scientifici ed educativi, io l'ho comprata a 60 € da 3B Scientific; è un oggetto progettato proprio per esperimenti sulla diffrazione da doppia fenditura.
Without any intention of disturbing quantum physics, I wanted a few days ago to try Young's classic experiment of the double slit on one of my hires solar spectrographs, HIRSS2, using sunlight, which, as is well known, is polychromatic and incoherent. I then bought an aluminum plate with over a series of three double slits of spaced each other of 200, 300 and 500 microns respectively, which I inserted into a swallowtail holder to alternately center the slit of interest. The plate is for sale by some distributors of scientific and educational tools, I bought mine at 60 € from 3B Scientific; Is an object designed for experiments on double slit diffraction.
Il mio interesse non era tuttavia solo quello di effettuare l'esperimento di Young tout court, ma :
1-Di effettuarlo con la luce solare, notoriamente policromatica ed incoerente.Tale esperimento, infatti, pur essendo relativamente facile con un laser a bassa potenza il cui fascio in uscita ha coerenza spaziale e temporale, diventa molto più complesso sulla luce solare che non presenta tali caratteristiche.
2-Di effettuarlo inviando il fascio diffratto dalla doppia fenditura ad uno spettroscopio autocollimante e per esso al reticolo, facendogli subire una seconda diffrazione, per osservare gli effetti sugli spettri dei vari ordini, il primo particolarmente.Per tale esperimento ho usato HIRSS2, un Littrow con reticolo da 1800 l/mm ottica a rifrazione formata da un rifrattore acro 100/500, al quale il fascio luminoso in arrivo (luce solare) viene inviato da un altro rifrattore acro 80/400.Tale spettroscopio è peraltro un ottimo strumento, che permette di ottenere risoluzioni sino a 40000 sullo spettro solare, come si osserva dall'immagine dello spettro della zona della riga H alfa.
My interest, however, was not just to carry out the Young
experiment tout court but:
1-Do it with sunlight, notoriously polychromatic and incoherent. This experiment,
while being relatively easy with a low power laser whose output beam has spatial
and temporal coherence, becomes much more complex on sunlight that hasn't such
features.
2-Do it by sending the diffracted beam from the double slit to a Littrow
spectroscope and for it to the grating, causing it to undergo a second
diffraction, to observe the effects on the spectra of the various orders, the
first particularly. For such experiment I used HIRSS2, a Littrow autollimating
spectroscope with a 1800 l / mm grating and using as collimator an
acro 100/500 refractor, to which the incoming light beam (sunlight) is sent by
another 80/400 acro refractor . This spectroscope is a great instrument, which
allows to obtain resolutions up to 40000 on the solar spectrum, as seen from the
spectrum image of the H alpha zone below.
Dopo alcune prove preliminari che mi hanno portato ad una migliore comprensione del problema, che non è banale , ho deciso di operare secondo la seguente modalità:
1- Effettuare la prima parte dell'esperimento escludendo lo spettroscopio autocollimante, ovvero semplicemente rivolgendo il prisma del deviatore (estraibile e mobile) verso il rifrattore 80/400 e la luce solare in arrivo.Per rendere la luce solare monocromatica ho usato un primo filtro Halpha da 50.8 mm da 35 nm di bandpass anteposto all'obiettivo del rifrattore ed un secondo filtro Halpha più selettivo da 10 nm all'ingresso della camera; per darle coerenza spaziale ho invece usato un foro stenopeico da 100 micron posto nel portaoculari del rifrattore, secondo lo schema e la foto che seguono. La camera usata è stata una IS DMK 41 1280 x 960 pixel da 4.5 micron, mentre la doppia fenditura usata è stata quella con la separazione minima, di 200 micron tra le aperture di 70 micron ciascuna.
Lo schema del sistema usato per rendere coerente il fascio di luce solare in ingresso
After some preliminary tests that led me to a
better understanding of the problem, which is not trivial, I decided to operate
in the following way:
1- Take the first part of the experiment by excluding the auto-collimating
spectroscope, simply by turning the diverter prism (removable and mobile)
towards the refractor 80/400 and the incoming sunlight. To make solar
light monochromatic I used a first Halpha prefilter 50.8 mm of 35 nm of
bandpass put in front of the 80/400 refractor lens and a second Halpha filter
10nm bandpass, more selective, at the camera entrance; To give i spatial
coherence to the beam, I used a 100 micron pinhole in the refractor
eyepiece holder, according to the diagram and the following picture. The camera
used was an IS DMK 41 1280 x 960 pixels of 4.5 microns, while the double slit
used was the one with the minimum separation of 200 micron between the apertures
of 70 microns each.
Here below the system used to make the incoming sunlight beam coherent.
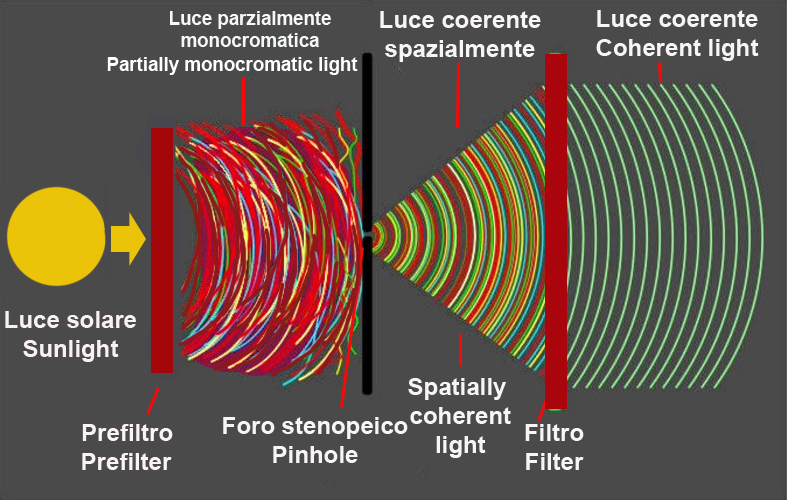
Il layout dello strumento usato ed una sua foto
The layout of the instrument and a photo
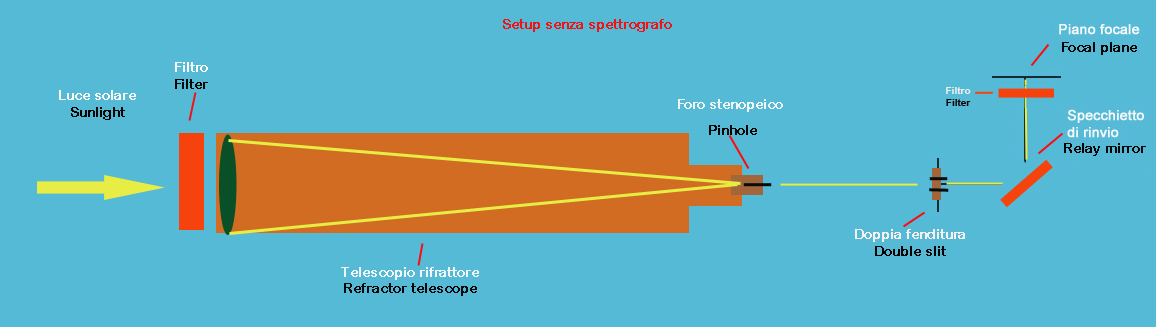

Il risultato è stato pienamente soddisfacente, oltre le mie aspettative, in quanto la camera ha restituito un'immagine del pattern di diffrazione da doppia fenditura: perfettamente uguale a quello che si può trovare sui libri o sugli articoli specialistici (il profilo è stato ricavato con VSpec).
The result fully satisfied me, beyond my espectations, for the camera gave an image of the double slit diffraction pattern almost equal to the one we can find on the books or in the articles.(the profile was obtained by VSpec).
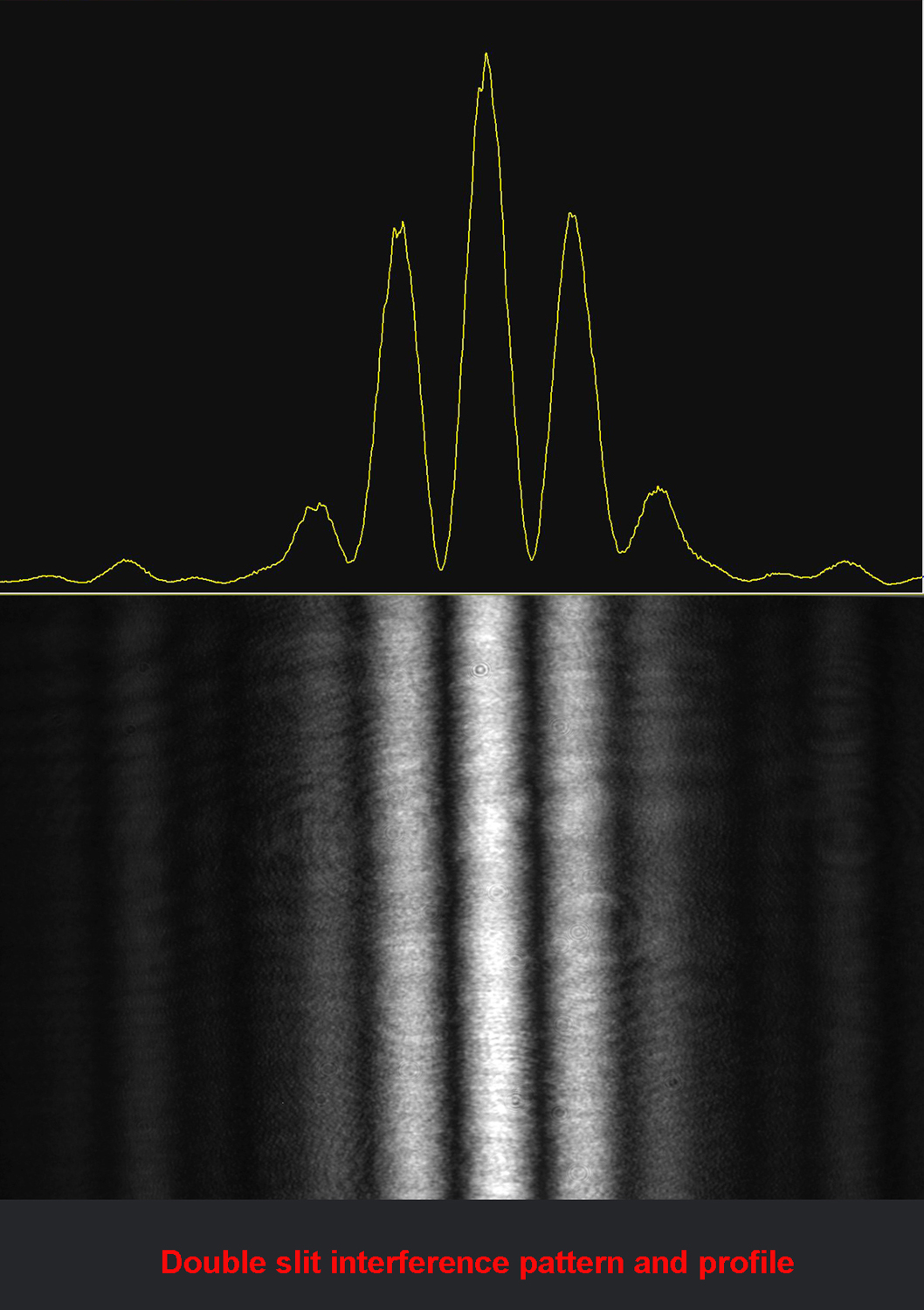
La seconda parte dell'esperimento, quella più interessante,aveva lo scopo di far subire al fascio ottico diffratto dalla doppia fenditura una seconda diffrazione ad opera del reticolo da 1800 l/mm dello spettrografo per osservare l'immagine finale .Un esperimento semplice, ma non banale, di diffrazione multipla od in serie.Il prisma deviatore dello spettrografo era stato stavolta rivolto verso il reticolo, come nel normale layout di un autocollimante Littrow.
The second part of the experiment, the most interesting , was to make the beam diffracted by the double slit perform a second diffraction by the 1800 l / mm grating of the spectrograph to observe the final image. A simple experiment not trivial,of multiple or serial diffraction. The spectrograph divergent prism had been pointing toward the grating, as in the normal layout of a Littrow spectroscope.
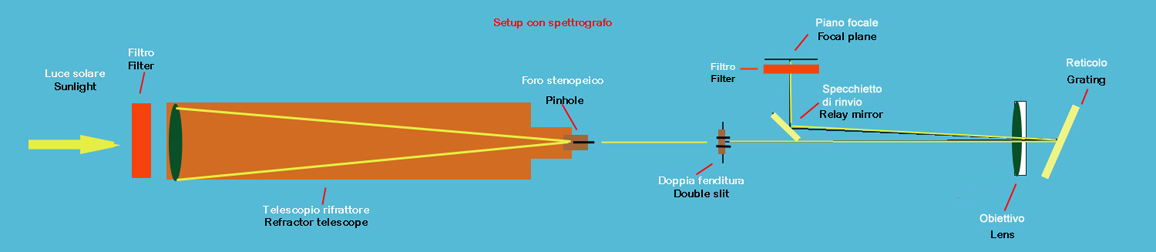
Senza l'uso del foro stenopeico in uscita del rifrattore 80/400 , con il collimatore 100/500 dello spettrografo focheggiato, come normale sulla fenditura doppia,con la parte posteriore dell'obiettivo a 460 mm di distanza dalla fenditura stessa (460 e non 495-500 in quanto i punti di fuoco delle due ottiche si intersecano),e puntato sulla riga H alpha a 6562.8 A ottenevo un'immagine doppia della riga, e quindi due spettri sovrapposti , anche se distanziati tra loro in proporzione alla distanza tra le due fenditure.L'immagine spettrale era flou per la scarsa risoluzione fornita dall'apertura delle due fenditure (solo 70 micron).Il risultato si spiegava, a mio avviso, col fatto che la luce in arrivo sulla doppia fenditura era incoerente e quindi la stessa operava come una semplice maschera.La diffrazione di Young in tal caso non aveva luogo, ed avveniva solo quella operata dal reticolo dello spettrografo.
Without the use of the pinhole in exit from the 80/400 refractor with the 100/500 collimator of the spectrograph,focused as normal, on the double slit, with the back of the lens at 460 mm distance from the slit (460 And not 495-500 as the focal points of the two optics intersect each other), and pointing to the line H alpha at 6562.8 A I obtained a double line image, and hence two overlapping spectra, although spaced apart in proportion to the distance between the two slits. The spectral image was flush due to the low resolution provided by the opening of the two slits (only 70 micron). The result was explained, in my opinion, by the spatial incoherence of the light on the double slit so the same worked as a simple mask. Young's diffraction in that case did not take place, but only that operated by the grating of the spectrograph .
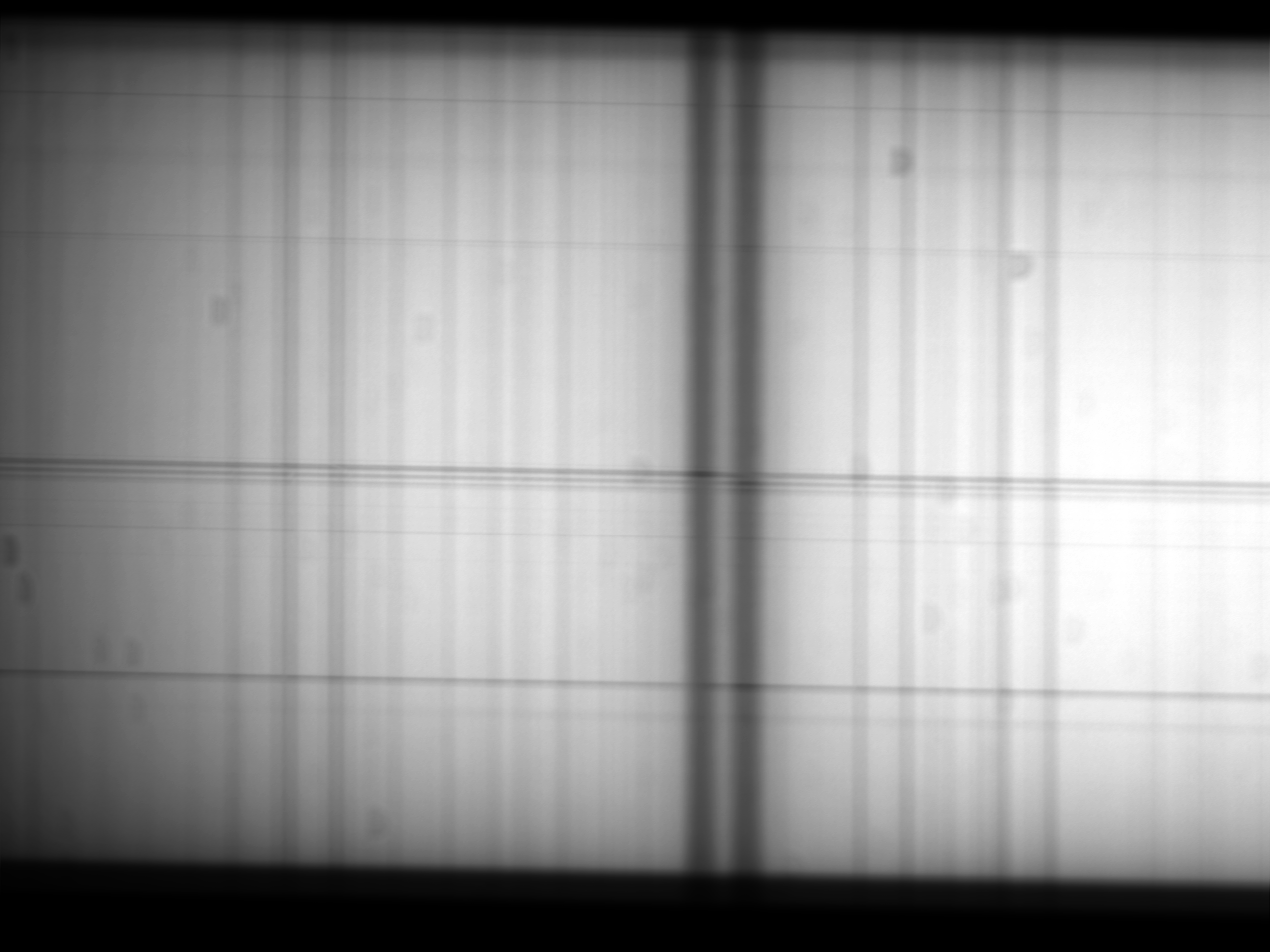
Con l'uso del foro stenopeico da 100 micron come filtro spaziale l'esperimento entrava nella sua parte più interessante, ma anche più complicata in quanto :
1- Dovevo accertarmi che effettivamente la diffrazione di Young avesse luogo anche successivamente al passaggio sul reticolo dello spettrografo, isolando questo dallo strumento, in parole povere facendolo operare solo come semplice reticolo; e per fare questo era necessario che l'ottica dello spettroscopio non fosse a fuoco sulla doppia fenditura, ma focheggiata molto più avanti di questa.Ho ottenuto ciò portando la fenditura stessa a 495 mm di distanza dalla lente posteriore dell'obiettivo 100/500 dello spettrografo.
In tale configurazione, senza foro stenopeico, si otteneva la seguente immagine: senza alcuna riga, simile ad una flat del sensore della camera.
With the use of the 100 micron pinhole as spatial filter, the experiment became more interesting, but also more complicated as:
1- I had to make sure that Young's diffraction took place even after
passing on the grating, isolating it from the instrument, in a word,
making it only act as a simple grating; And to do this it was necessary that the
spectroscope optic be not focused on the double slit, but focused much later
than this. I obtained this by carrying the slit at 495 mm distance from
the rear of the 100/500 collimating lens of the spectrograph.
In this configuration, without a pinhole, the
following image was obtained, with no line, similar to that of a camera flat.

Con l'uso del foro stenopeico,con luce in coerenza di fase, l'immagine mostrava invece, seppure in modo non chiaro, una replica del pattern di diffrazione di Young in assorbimento , nello spettro di ordine 1 del reticolo che non sembrava mostrare alcuna riga spettrale.
With the use of pinhole, with sunlight in spatial coherent beam, the image showed, although in a not fully clear way, a Young diffraction pattern in absorbtion in the 1st order spectrum of the grating, that seemed show no spectral line.
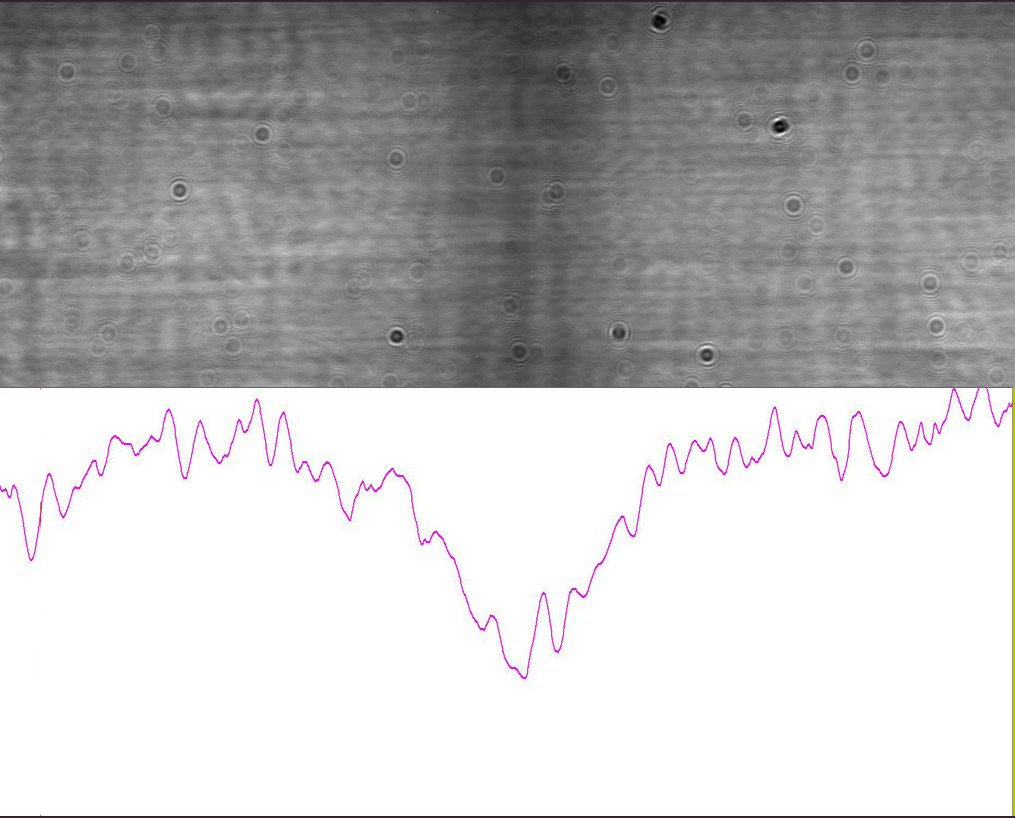
2-Con l'ottica dello spettroscopio focheggiata sulla fenditura si otteneva invece il seguente risultato:
2a- Senza foro stenopeico, una replica dell'immagine già mostrata in precedenza, con una riga Ha doppia e quindi la sovrapposizione di spettri sfalsati tra loro.
2-With the spectroscope optic focused on the double slit I obtained the following results:
2a Without pinhole, an image with two spectra, superimposed to each other, with two Ha lines.
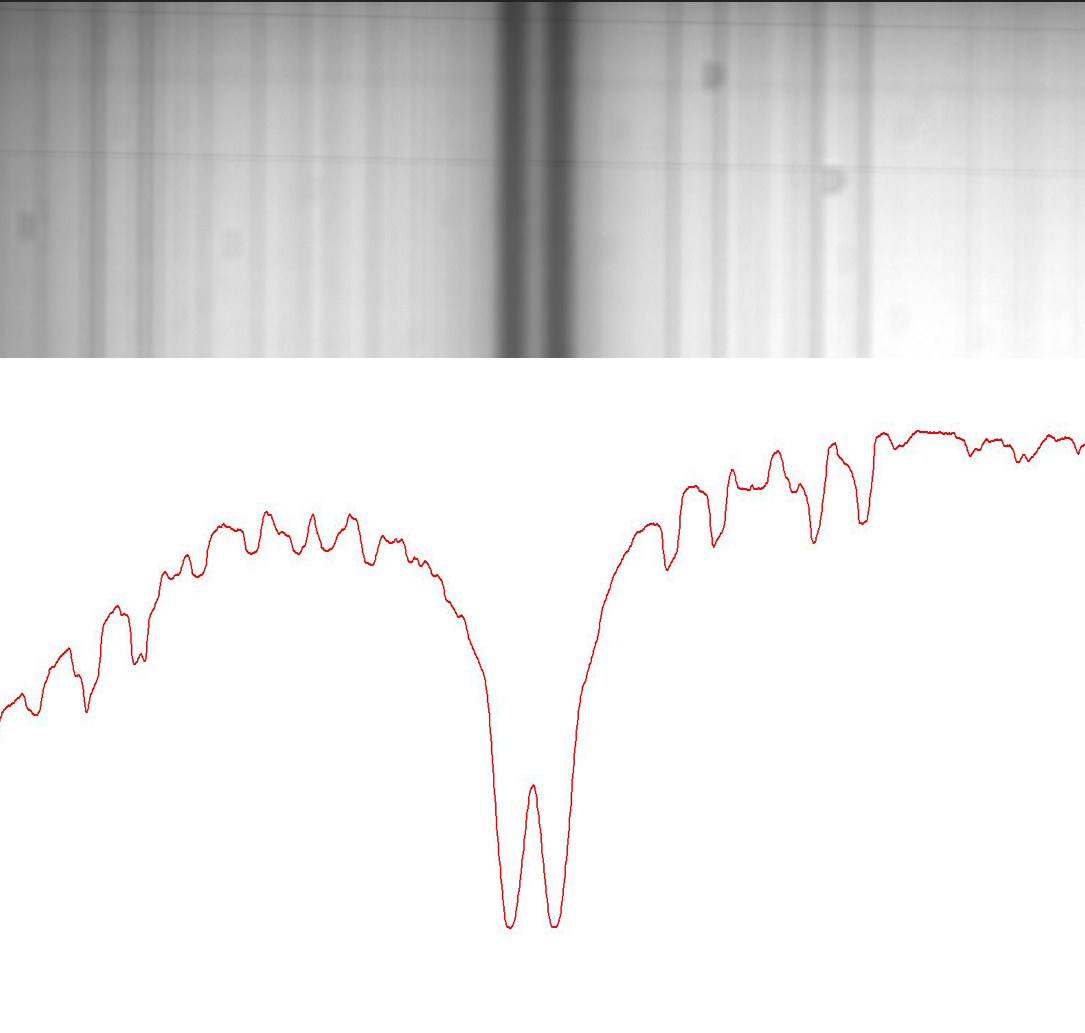
2b- col foro stenopeico da 100 micron:un'immagine simile alla precedente
2b- with the 100 micron pinhole, an image similar to the previous one
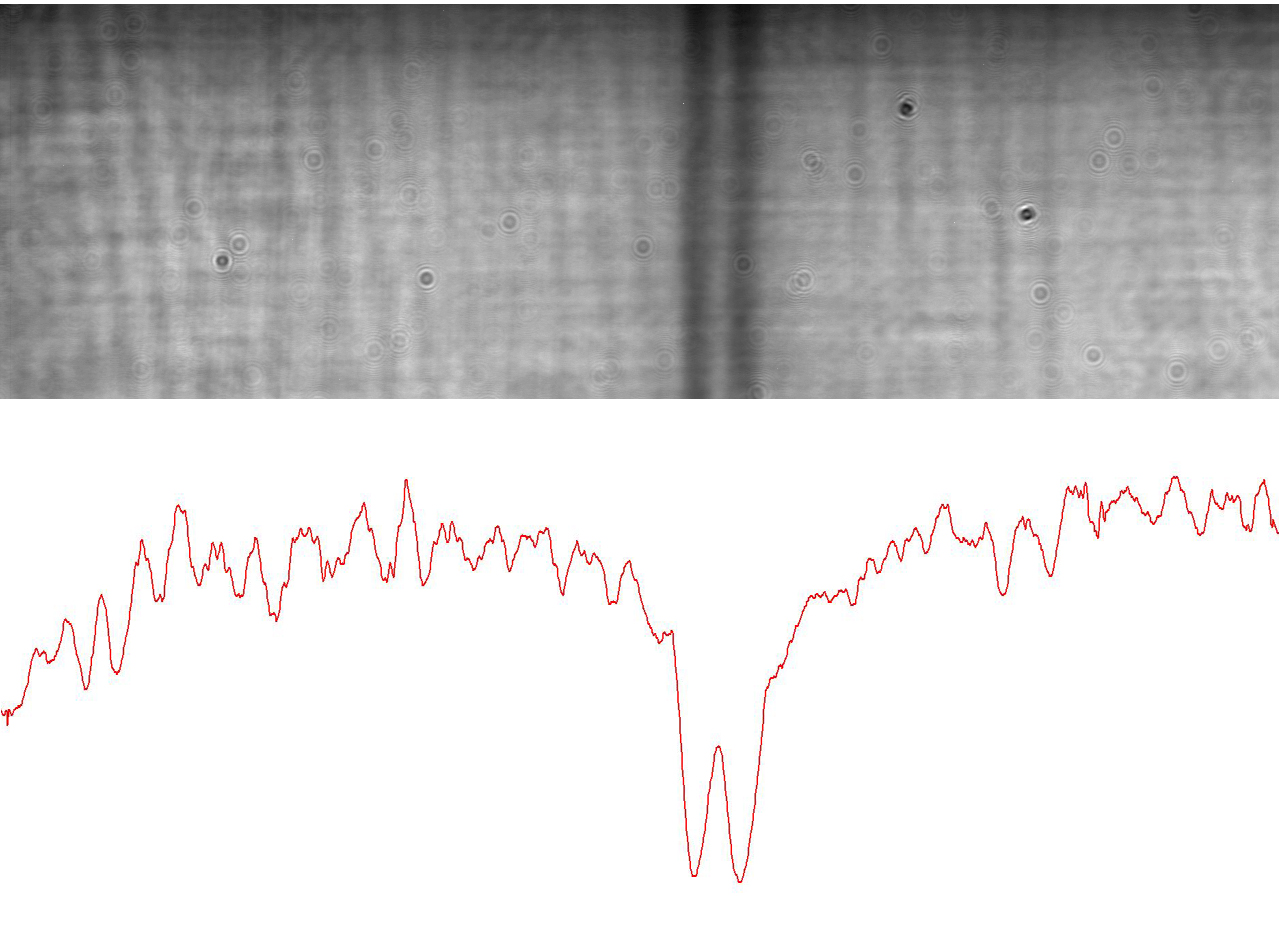
Ulteriori sviluppi ed il report completo dell'esperimento sono visibili al link:
Further developments and a complete report of the experiment are can be found at the link:
http://www.lightfrominfinity.org/Young%20Experiment/Young%20experiment.pdf
Le stelle WR,
scoperte dagli astronomi Wolf e Rayet all’Osservatorio di Parigi nel 1867, sono
stelle massicce e molto calde (30000-200000 K) caratterizzate da fortissimi
venti stellari (sino a 2000 kms), e da enormi perdite di massa : tali perdite di
massa provocano l’espulsione dello
strato superficiale di idrogeno sino a scoprire i nuclei più interni di elio.
Una caratteristica
peculiare di tali stelle è lo spettro, che presente righe in emissione molto
spesse,con predominanza di quelle dell’Elio, Carbonio, Ossigeno ed Azoto, a
seconda del tipo e quelle dell'Idrogeno deboli o assenti: lo spessore delle righe fu correttamente attribuito ad effetto
Doppler, il che fece ipotizzare un inviluppo gassoso che circondava le stelle e
si spostava velocemente rispetto alla linea di vista.Una prima classificazione
delle stelle WR fu effettuata sulla base dell’abbondanza o meno nei loro spettri
delle righe dell’azoto ionizzato (WN) o del carbonio ionizzato (WC) tali classi
furono poi divise in sottoclassi spettrali , rispettivamente da WN 2 a 11 e da
WC 4 a 11 a seconda, appunto, della presenza maggiore o minore delle righe di
tali elementi.Quanto alla loro evoluzione, si ritiene che parte delle stelle WR
di massa tra le 10 e 25 masse solari provenga da stelle di tipo O, altre, di
massa tra 25 e 30 M siano
l’evoluzione delle stelle
supergiganti rosse.Alle classi iniziali furono poi aggiunte quella WO (divisa in
4 sottoclassi da 1 a 4) , che è piuttosto una sottotipo delle WC con predominio
delle righe dell'ossigeno ionizzato; Alcune stelle WR sono ritenute essere progenitrici di supernovae di tipo Ib ed Ic, caratterizzate da mancanza delle righe
dell’Idrogeno, anche se sussiste un certo grado di incertezza in tale assunto,
ed addirittura di GRB.Le stelle WR emettono radiazione nell’UV e nei raggi X
ancor più che nel visibile.
In summary, the WR stars, discovered by the astronoms Wolf and Rayet at the
Paris Observatory in 1867, are massive and very hot stars (30000-200000 K)
featuring strong star stellar winds (up to 2000 kms) and massive mass losses :
Such mass leakage causes the superficial hydrogen layer to be expelled to
discover the more internal helium nuclei.
A peculiar characteristic of such stars is the spectrum, which has very thick
lines with predominance of those of Helium, Carbon, Oxygen and Nitrogen,
depending on the type: the thickness of the lines was properly attributed to
Doppler effect, which hypothesized a gaseous envelope surrounding the stars and
shifted rapidly from the view line. A first WR star rating was made based on the
abundance of their spectrum of ionized nitrogen (WN) or ionized carbon (WC),
these classes were then subdivided into spectral subclasses, respectively WN 2
to 11 and WC 4 to 9, depending on the presence or absence of the lines of these
elements. To the initial classes, followed later a third (WO) with abundance of
ionized oxigen lines. As to their evolution, it is believed that part of the Mass WR stars
between 10 and 25 solar masses come from O-type stars, others with masses
between 25 and 30 M are the evolution of the super-gigantic red stars. Some WR
stars are considered to be progenitors of type Ib and Ic supernovae,
characterized by lack of lines of hydrogen, although there is some degree of
uncertainty in that assumption, and even of GRB. WR stars emit radiation in the
UV and in the X-rays even more than visible.
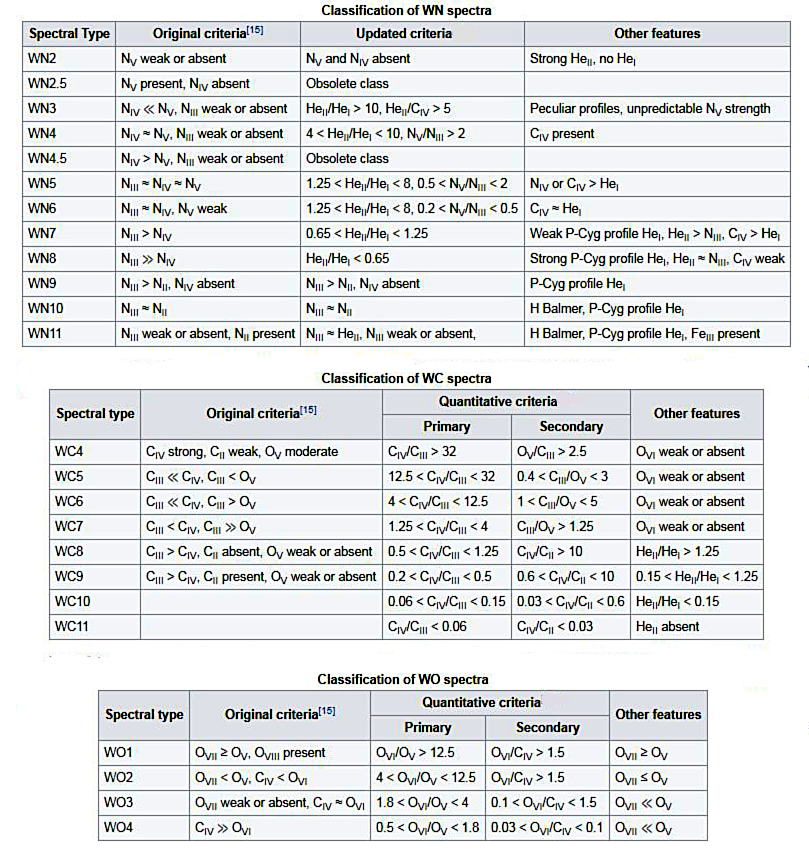
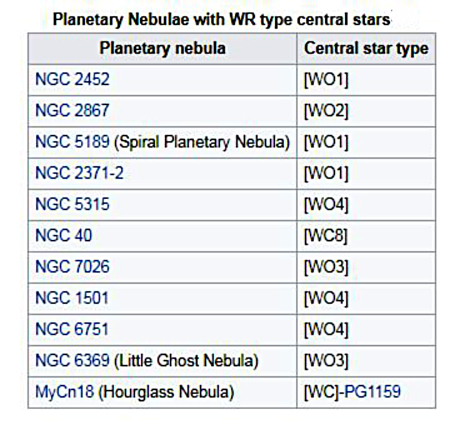
WR 133 è una stella di tipo Wolf-Rayet che si trova nella costellazione del Cigno all'interno dell'ammasso aperto NGC 6871. WR 133 si trova in un sistema binario ed orbita intorno ad una supergigante blu di tipo O9I in circa 112 giorni. Lo spettro risultante è pertanto la combinazione delle due stelle. La stella brilla con una magnitudine 6.75 V. Lo spettro mostra delle forti linee di emissione dell'elio ionizzato (He II) oltre alle caratteristiche linee di emissione dell'azoto ionizzato (N IV ed N V) e del carbonio ionizzato (C IV).
WR 133 is a Wolf-Rayet star located in the Swan Constellation within the NGC 6871 open cluster. WR 133 is in a binary system and orbit around a super-giant blue O9I spectral class in about 112 days. The resulting spectrum is therefore the combination of the two stars.The star shines with a magnitude of 6.75 V. The spectrum shows the strong ionized helium (He II) emission lines in addition to the characteristics of ionized nitrogen (N IV and N V) and ionized carbon (C IV) emission lines.
WR
133: Lo spettro di Lorenzo Franco con uno spettrografo Alpy 600
Lo spettro è stato acquisito da Roma il 20 ottobre 2017 con un telescopio da 20cm ed uno spettroscopio Alpy600 con 11 pose da 120s. Il profilo rettificato mette meglio in evidenza le caratteristiche dello spettro.
The spectrum by Lorenzo Franco was acquired from Rome, Italy, with a 20 cm scope and an Alpy 600 spectroscope, 11 frames 120 sec each.The rectified profile shows better the features of the spectrum.
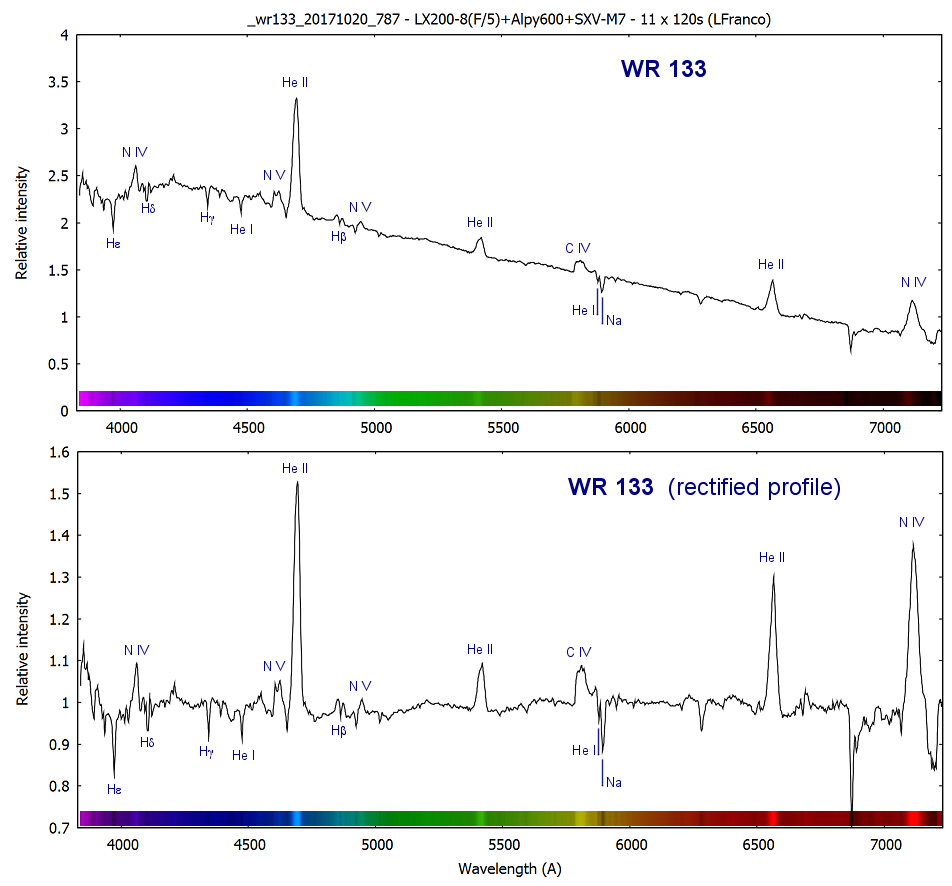
WR 133 Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo LHires III


Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani, nati
rispettivamente nel 1970 e nel 1971, sono astrofili fin dagli anni 80 e membri
dell'Associazione Astrofili Fiorentini dal 1988. Negli anni si sono dedicati
principalmente ad attività come fotometria, astrometria e, più di recente,
spettroscopia. Annoverano alcune scoperte effettuate insieme e nello specifico
la scoperta di un asteroide, l'identificazione della natura cometaria di un
altro asteroide, l'individuazione di 2 stelle variabili e la scoperta di una
stella Be.
Hanno infine firmato congiuntamente alcune pubblicazioni apparse sul Minor
Planet Bulletin e Atel, oltre a qualche sporadica collaborazione con le riviste
italiane Coelum e Nuovo Orione.
Hanno infine fondato e costruito l'Osservatorio Astronomico Margherita Hack
(A57), da cui svolgono le loro attività osservative da circa 2 anni.
Massimiliano Mannucci
and Nico Montigiani, born respectively in 1970 and 1971, have been amateur
astronomers since the 80s and members of the Associazione Astrofili Fiorentini
since 1988. Over the years they have mainly focused on activities such as
photometry, astrometry and, more recently, spectroscopy. They include some
discoveries made together and specifically the discovery of an asteroid, the
identification of the cometary nature of another asteroid, the identification of
2 variable stars and the discovery of a star Be.
They finally jointly signed some
publications appeared on the Minor Planet Bulletin and Atel, as well as some
sporadic collaboration with the Italian magazines Coelum and Nuovo Orione.
Finally, they founded and built the
Margherita Hack Astronomical Observatory (A57), from which they have been
carrying out their observational activities since about 2 years.
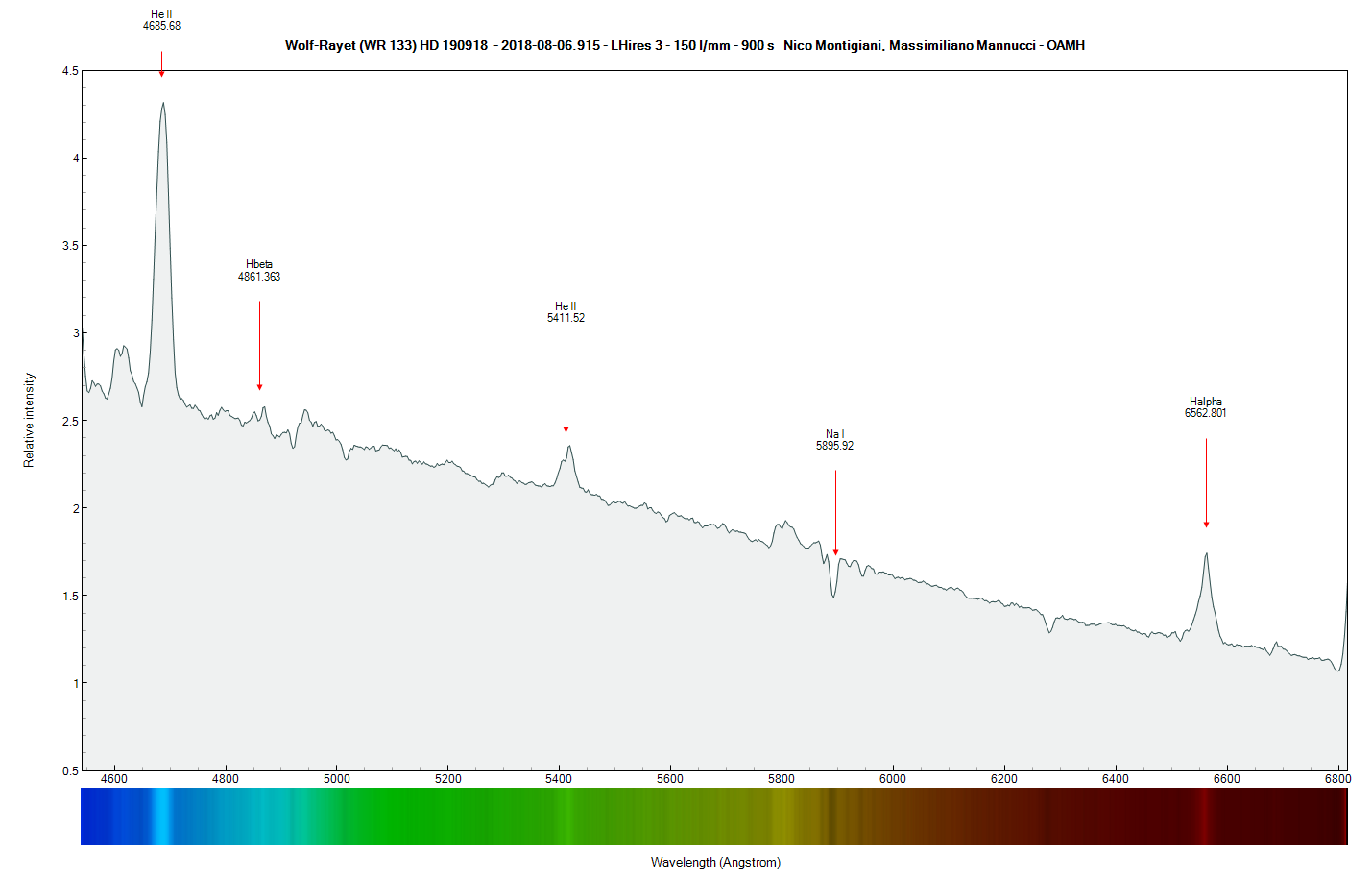
In the image following the spectral profile of the star, obtained by Lorenzo
Franco with an Alpy 600 Spectrographer at the focus of a 8" Meade LX200 (stacking
5 frames by 180 sec).
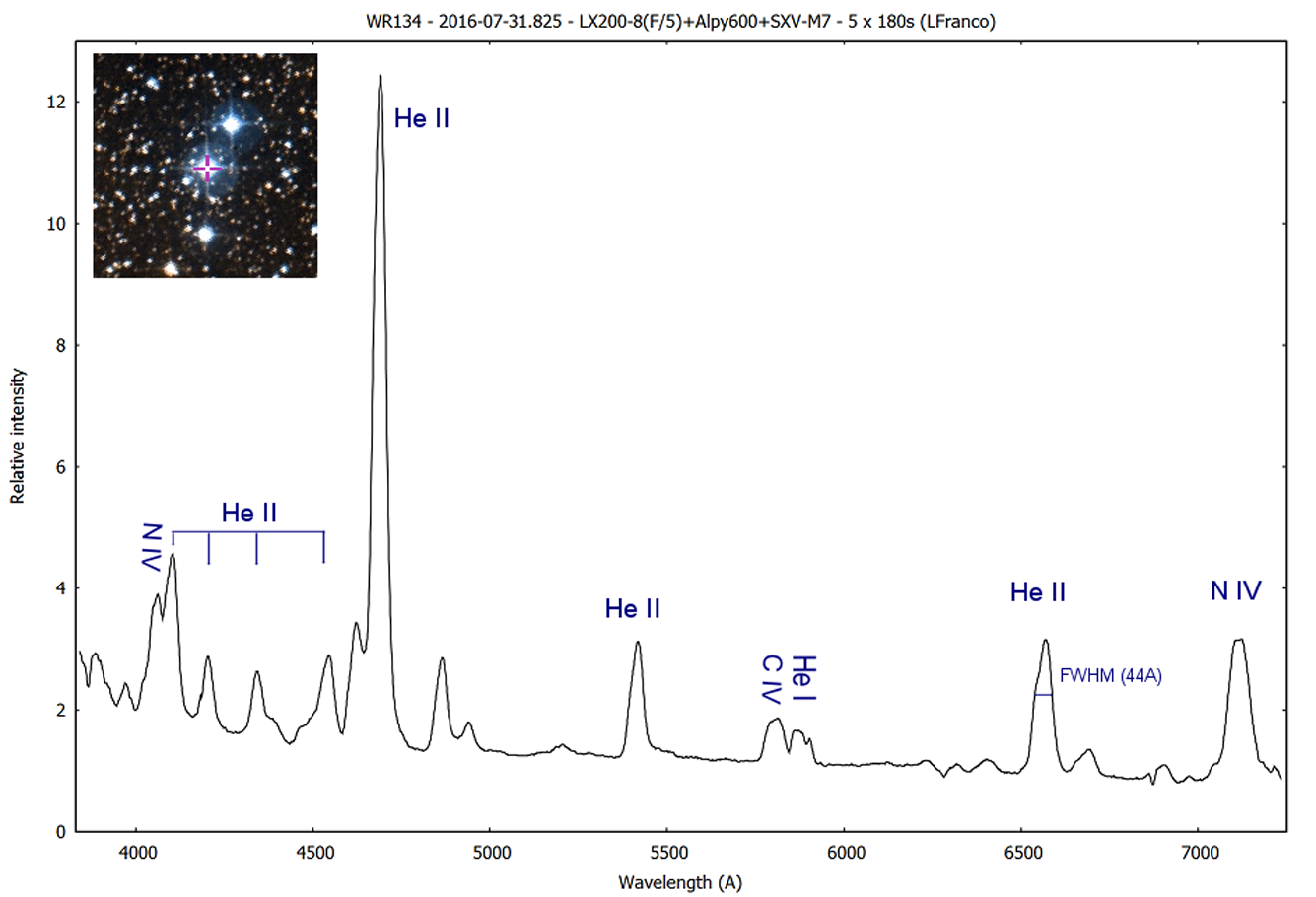
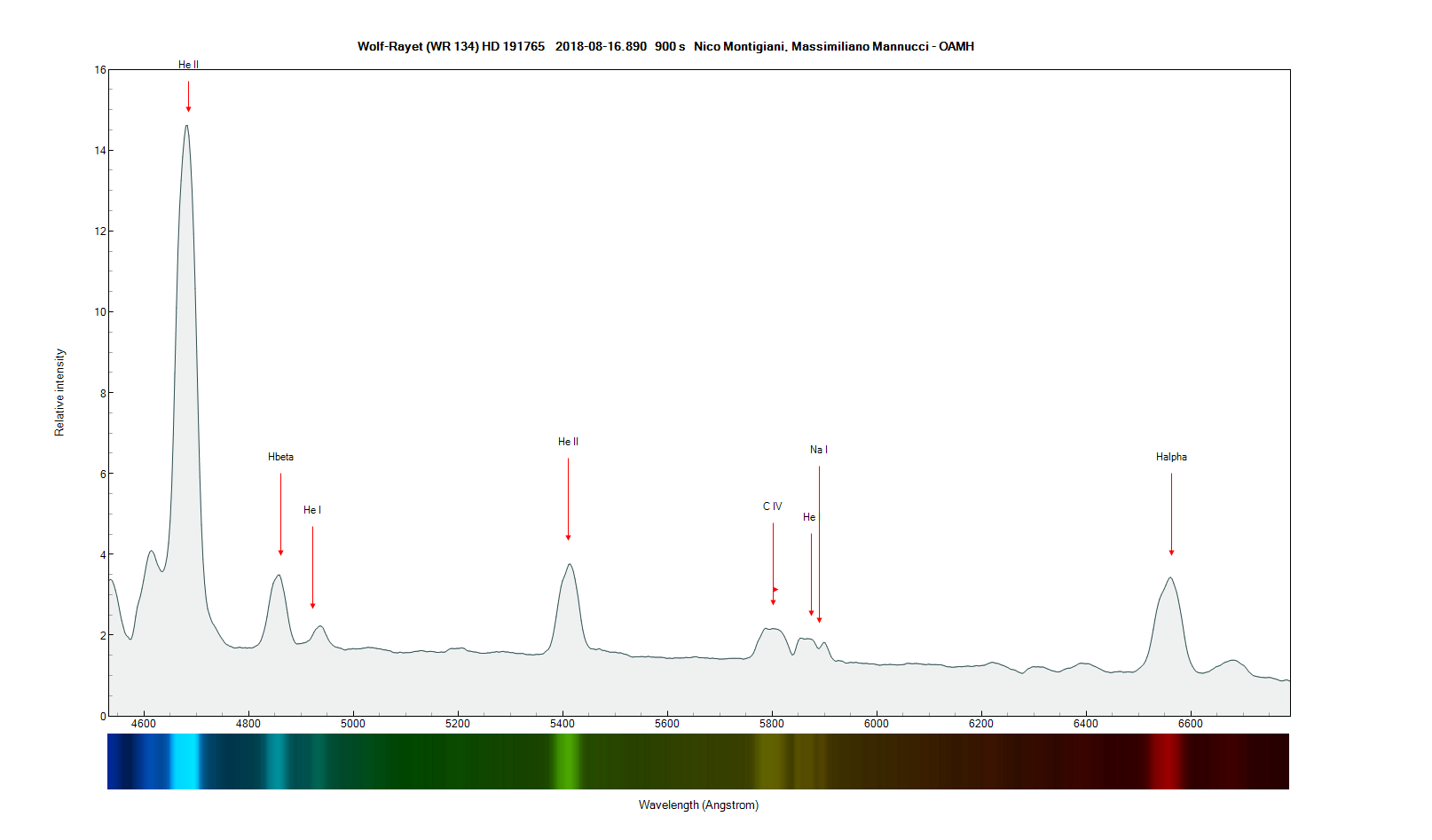
WR 135: Lo spettro di Fulvio Mete con lo Spec 600
La
HD 192103 – WR 135 è
una WR diclasse WC 8, con predominanti le righe del carbonio La classe spettrale
WC8 è caratterizzata da una temperatura superficiale di 65.000 K ed un vento
stellare da ca
Lo
spettro ,ripreso a luglio 2019 col mio spettrografo Spec 600 al fuoco di un
Celestron
Alcune righe sono in blend tra loro, per la bassa risoluzione del sistema, ma
restano comunque predominanti quelle del carbonio due volte e tre volte
ionizzato CIII e CIV, come si osserva nella seconda immagine del profilo. La
stella in questione è stata anche oggetto, insieme ad altre WR, di una campagna
osservativa diffusa dall’AAVSO, ed ancora in corsohttps://www.aavso.org/category/tags/wr-135.
La
prima immagine è quella del profilo, la seconda del contributo delle righe del
carbonio allo stesso, la terza quella della posizione della fenditura sulla
stella come osservabile dalla mia camera di guida Lodestar.
The
HD 192103 - WR 135 is a WR diclasse WC 8, with predominantly carbon lines The
WC8 spectral class is characterized by a surface temperature of 65,000 K and a
stellar wind of about 1700 km sec. The spectrum, taken in July 2019 with my Spec
600 spectrograph at the focus of a Celestron 8 at f 6.3, was obtained with 6
frames at 300 sec each in 2x2 binning with the Atik 16 HR camera which is an
integral part of the spectrograph. The indication of the elements of the lines
of the profile was made on the basis of the Visual Spec routines "Lineident" and
"WR" and of the professional work done by AB Underhill on the WR in question
http://adsabs.harvard.edu/full/ 1960PDAO ... 11..209U.
Some lines are blended together due to the low resolution of the system, but
those of carbon twice and three times ionized CIII and CIV remain predominant,
as can be seen in the second image of the profile. The star in question was also
the subject, together with other WRs, of an observational campaign promoted by
the AAVSO, and still in progress https: //www.aavso.org/category/tags/wr-135.
The first image is that of the profile, the second of the contribution of the
carbon lines to the same, the third that of the position of the slit on the star
as observable from my Lodestar driving camera.
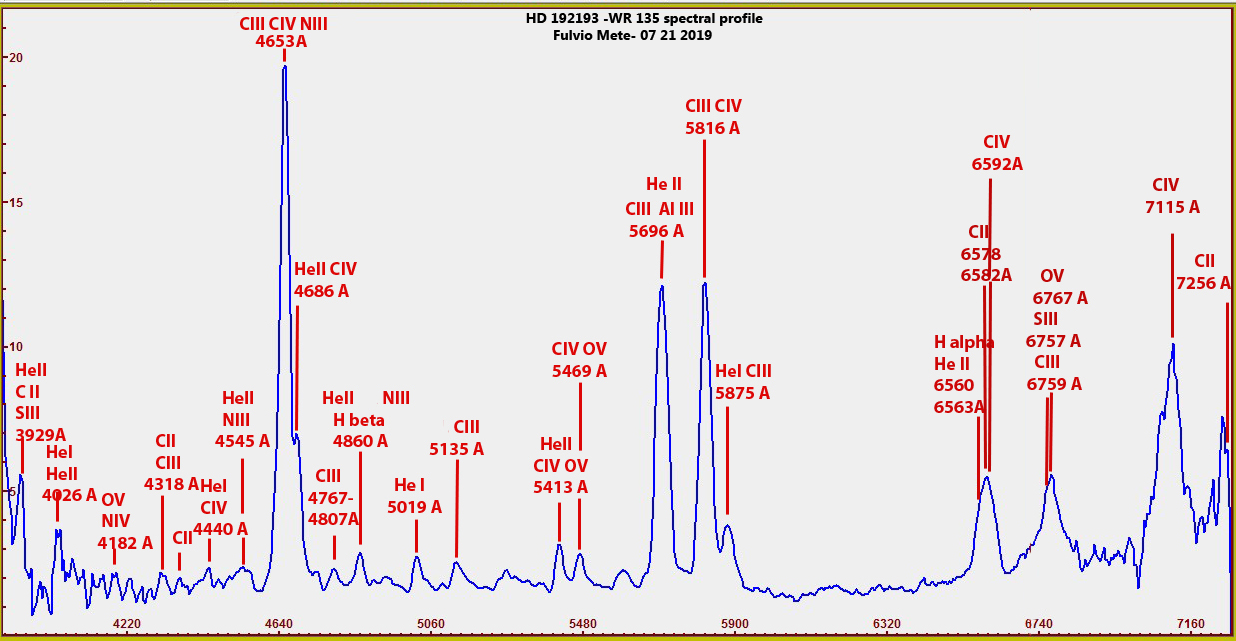
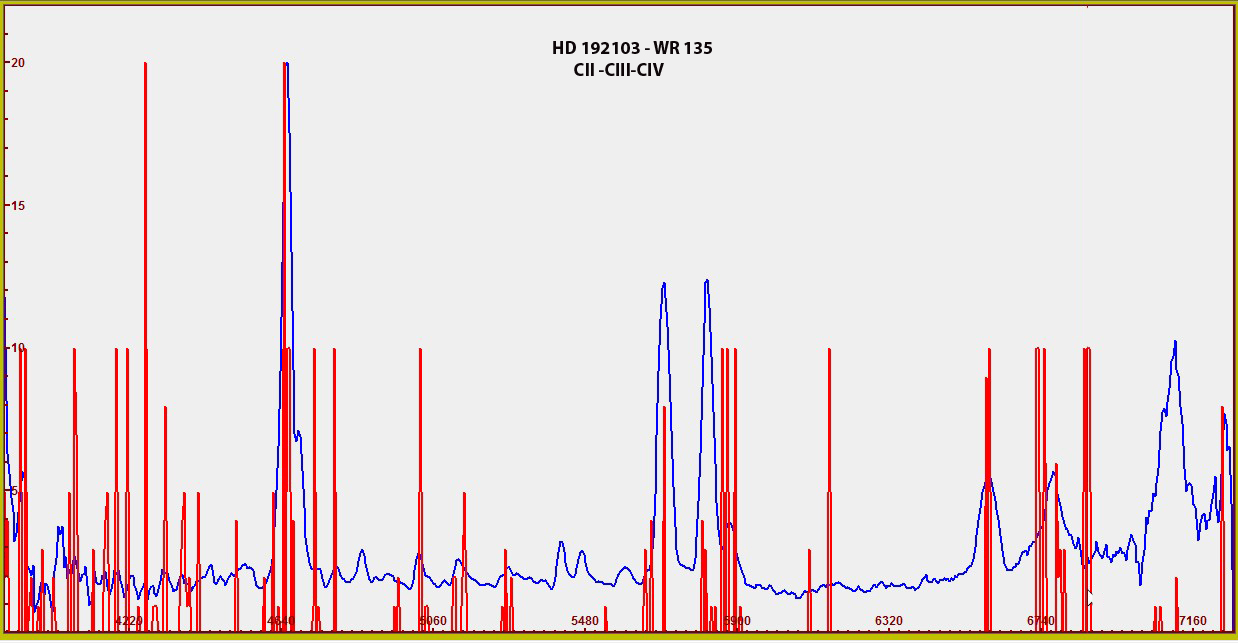
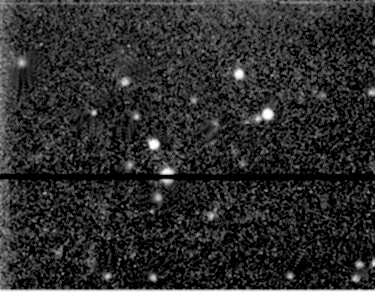
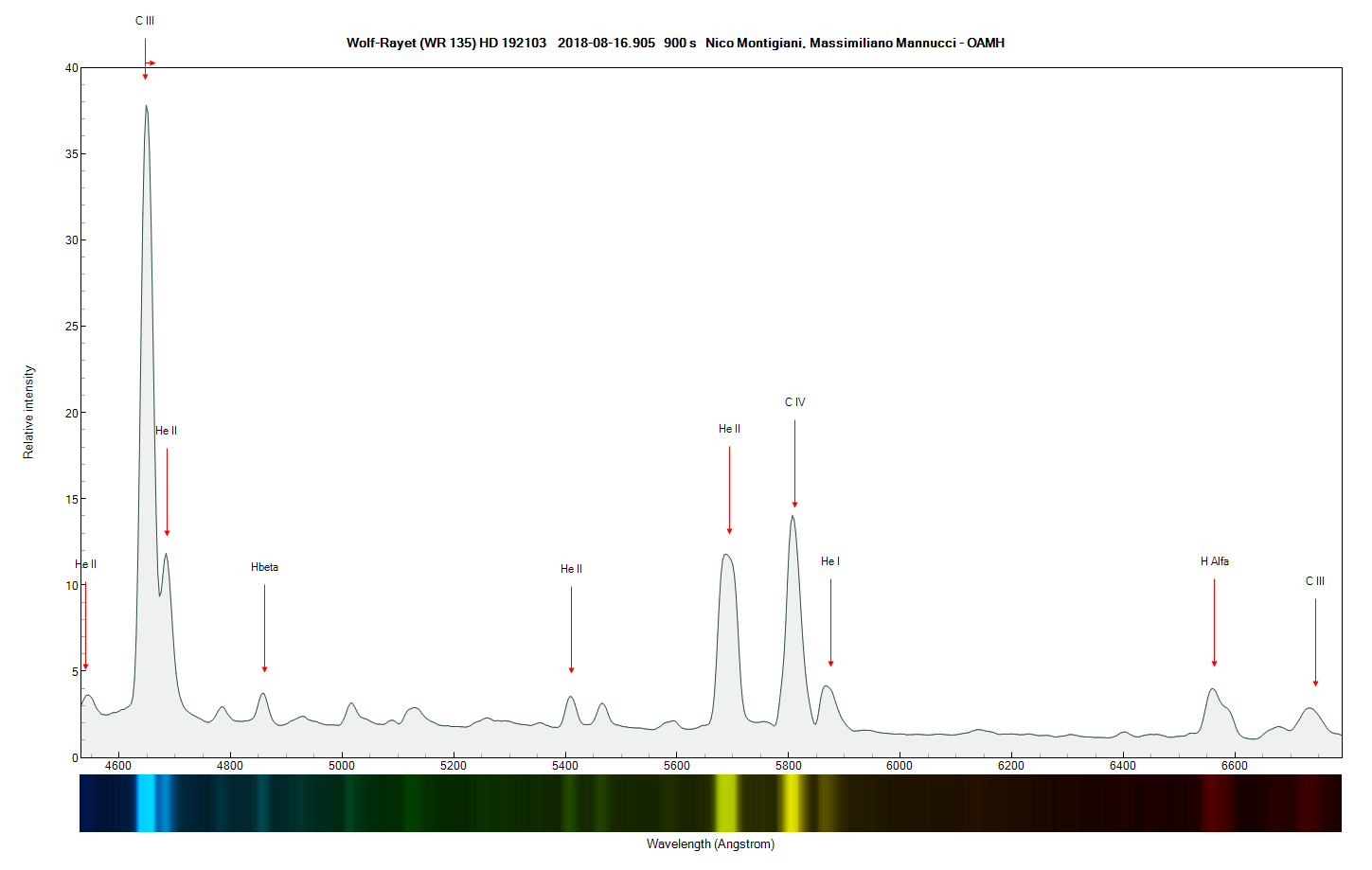
Nessun astrofotografo che
si rispetti può aver mancato di riprendere od osservare NGC 6888, la famosa “Crescent
Nebula”, che prende il suo nome dall’apparente forma di luna crescente.Si tratta
infatti di un oggetto facile da individuare, dato che si trova a soli 2 gradi a
sud ovest di Sadr, la stella gamma del Cigno, e che culmina allo zenith nelle
ore serali del mese di luglio, quando l’osservazione e la ripresa di oggetti
celesti è maggiormente agevole e divertente per le condizioni ambientali, anche
in siti montani.
Pochi tuttavia sanno che
tale nebulosa, che dista circa 5000 AL da noi, è uno dei pochissimi esempi di
“WR Nebula” galattica, ovvero di nebulosa ad emissione alimentata da una stella
di Wolf Rayet , la 136, situata nella sua zona centrale.
No respected amateur astronomer may have failed to observe NGC 6888, the famous
"Crescent Nebula", which takes its name from the apparent crescent moon. It is
an easy object to locate, since it is situated in just 2 degrees southwest of
Sadr,in the Swan , and culminating in zenith in the evening hours of July, when
observing and shooting celestial objects is easier and fun for environmental
conditions, even in mountain sites.
Few, however, know that this nebula, which is about 5,000 AL from us, is one of
the very few examples of galactic "WR Nebula", or emission nebula powered by a
Wolf Rayet star 136, located in its central area.

Ngc 6888 con le nebulosità
che la circondano.Foto di Fulvio Mete il 16 agosto 2017 da gli Altipiani di Arcinazzo (FR)a 900 mt di altitudine, con un Celestron 8 a f 6.3, una camera
Sbig ST10 XME ed un filtro H alpha Astronomik da 6 nm: stacking di 4 frames da
1200 sec l’uno.
Ngc 6888 with the nebulae surrounding it. Photo of the author on August 16, 2017
from the Altipiani of Arcinazzo (FR) at 900 mt altitude, with a Celestron 8 at f
6.3, a Sbig ST10 XME camera and a H alpha Astronomik filter 6 nm bandpass:
stacking of 4 frames of 1200 secs
each.
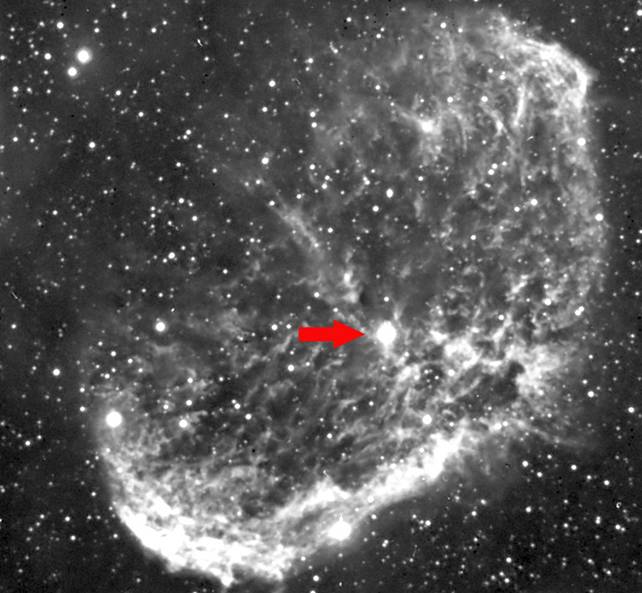
Nel crop soprastante si
osserva la posizione centrale della WR 136 e si notano i vari punti di
shock della shell.
In the
cropped image you can observe the central position of WR 136 in the nebula an d the
various shock points in the shell.
La WR 136 (HD 192163),
posta al centro di NGC 6888, è classificata come WN 6, con le righe
dell’Idrogeno assenti, quelle dell’azoto ionizzato di intensità inferiore a
quelle dell’Elio, e con quelle dell’Elio ionizzato invece ben presenti ed
intense.Essa ha una massa pari a 15 volte quella del sole ed una luminosità di
250.000 volte maggiore.La sua temperatura superficiale è di circa 70.000 K, e
l’emissione è particolarmente forte nel dominio UV.La sua magnitudine apparente
è di 7.5.
Circa 120-240000 anni fa,
divenuta una gigante rossa, la stella espulse una grande quantità di materia,
che ancora oggi si espande a circa 80 Kms.Contemporaneamente il forte e veloce
vento stellare viaggia alla velocità di circa 1700 Kms e, collidendo con la
materia espulsa in precedenza , dà origine alla shell osservata di Ngc 6888 ed a
due onde d’urto, una diretta verso l’esterno, ed una verso l’interno.La seconda
riscalda il vento stellare sino all’emissione di radiazione X.
The WR 136 (HD 192163), located at the center of NGC 6888, is classified as WN
6, with absent hydrogen lines, those of ionized nitrogen of less intensity than
that of helium, and those of the ionized helium well present and intense. It has
a mass of 15 times that of the sun and a brightness of 250,000 times greater.
Its surface temperature is about 70,000 K, and the emission is particularly
strong in the UV domain.
Its
apparent magnitude Is 7.5.
About 120 to 240000 years ago, becoming a red giant, the star expelled a large
amount of matter, which still expands today to about 80 kms. At the same time,
the strong and fast wind stellar travels at a speed of about 1700 Kms and
colliding with material expelled earlier, gives rise to the observed Ngc 6888
shell and two shock waves, one directed outward and one inward. The second warms
the star wind up to the X radiation emission.
La ripresa dello spettro
della WR 136 è stata effettuata il 12 agosto 2017 dalla medesima località,
utilizzando lo spettroscopio stellare a bassa risoluzione (R= 500) “Spec 600”
progettato e realizzato dall’autore, al cui fuoco è posta una camera CCD Atik 16
HR con un sensore Sony ICX 285 AL, particolarmente indicato per applicazioni
spettroscopiche per l’eccellente QE ed il basso rumore termico: la camera è
stata usata in binning 1x1.Il telescopio utilizzato è stato un Celestron 8
vintage, uno dei primi costruiti nel marzo 1970, che si è dimostrato
particolarmente adatto per spettroscopia, montato su una Skywatcher EQ6 pro..La
camera di guida (per guidare direttamente sulla stella in fenditura attraverso
il modulo di guida) una SX Press Lodestar (setup nelle foto che seguono).
Imaging of the WR 136 spectrum was carried out on August 12, 2017 from the same
location, using the low-resolution (R = 500) "Spec 600" spectroscope designed
and constructed by the author, with a CCD Atik 16 HR camera with a Sony ICX 285
AL sensor, particularly suitable for spectroscopic applications for excellent QE
and low thermal noise. The telescope used was a vintage Celestron 8, one of the
first built in March 1970, which proved to be particularly suitable. The camera
was used in 1x1 binning. The driving camera (to drive directly to the star in
the slit through the driving module) is an SX Press Lodestar ( the whole setup
is pictured below).
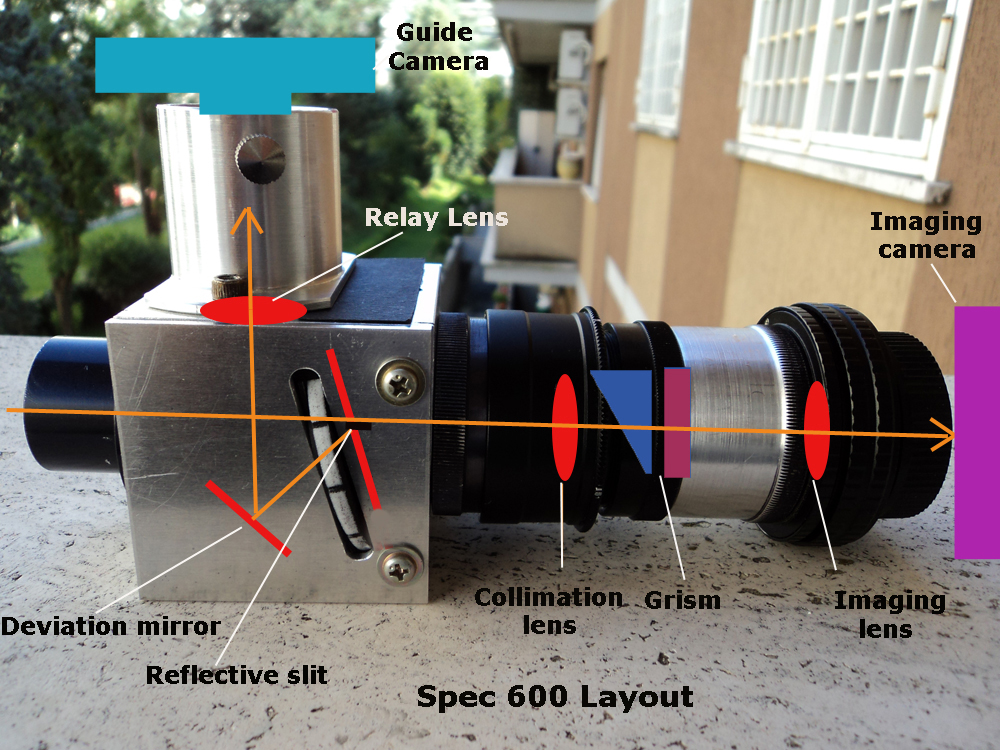
Il setup, con un venerabile SC Celestron da 8" del marzo 1970 e una montatura EQ6 pro.
The setup , with a vintage, venerable Celestron 8" Schmidt Cassegrain and an EQ6 pro mount

Premetto che entrambi gli
oggetti, la NGC 6888 e la WR 136 sono stati oggetto di studio approfondito, in
sede professionale, dal dominio X, a quello UV,
a quello radio, tuttavia sono presenti i contributi nel visibile.
In sede amatoriale, gli
spettri nel visibile della WR 136 si contano sulle dita di una mano.Lo spettro
bidimensionale della stella è stato ottenuto dallo stacking di 7 frames da 600
secs l’uno ottenuti con la strumentazione predetta, autoguidati sulla stessa
stella come appariva in fenditura dello spettroscopio attraverso la camera
posizionata nel modulo di guida.
Both objects, the NGC 6888 and WR 136, have been subjected to extensive study,
from the X ray, to the UV domain, to the radio, but there are also contributions
in the visible.
Amateur spectra in the visible of WR 136 count on the fingers of a hand. The
two-dimensional spectrum of the star was obtained by stacking 7 frames of 600
secs each the one obtained with the instrumentation predicted, self-guided on
the same star as it appeared in the slit through the camera positioned in the
guiding module.
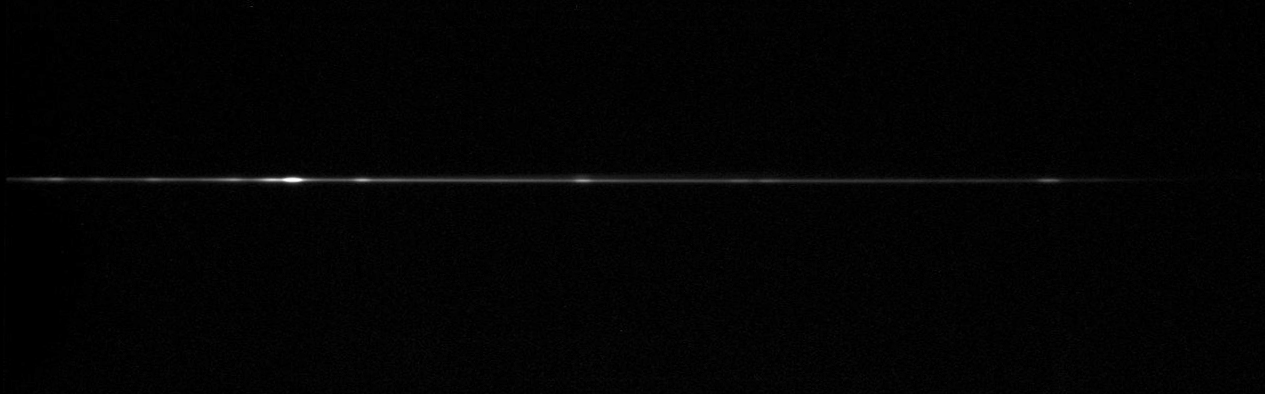
Il profilo
spettrale,ottenuto con Visual Spec, normalizzato e corretto per la risposta,
dispersione 2.4 A/pix,
va da 3983 a 6804 A.Esso appare canonico e conforme alle caratteristiche
della classe WN 6, con la mancanza delle righe dell’Idrogeno e con l’intensità
delle righe dell’Elio ionizzato che predomina su quelle dell’N III e dell’N IV,
presenti, ma deboli .Il rapporto He II/He I, misurato sulle righe He II a 4686 e
He I a 5876 A,è risultato pari a 10.4/1.8 = 5.77 e quindi compreso tra 1.25 ed
8.L’intensità relativa del C IV appare tuttavia inferiore va quella dell’He I,
anche se di poco (1.6 vs 1.8).
The spectral profile, obtained with Visual Spec software, normalized and
corrected for the response ranges from 3983 to 6804 A. It appears canonical and
conforms to the WN 6 class features, with the absence of the lines of the
Hydrogen and the intensity of the lines of the ionized helium He II that
predominates on those of N III and N IV, present but weak. The He II / He I
ratio, measured on lines He II at 4686 and He I at 5876 A, was equal to 10.4 /
1.8 = 5.77 and therefore between 1.25 and 8. However, the relative intensity of
C IV appears lower than that of He I, albeit low (1.6 vs. 1.8).
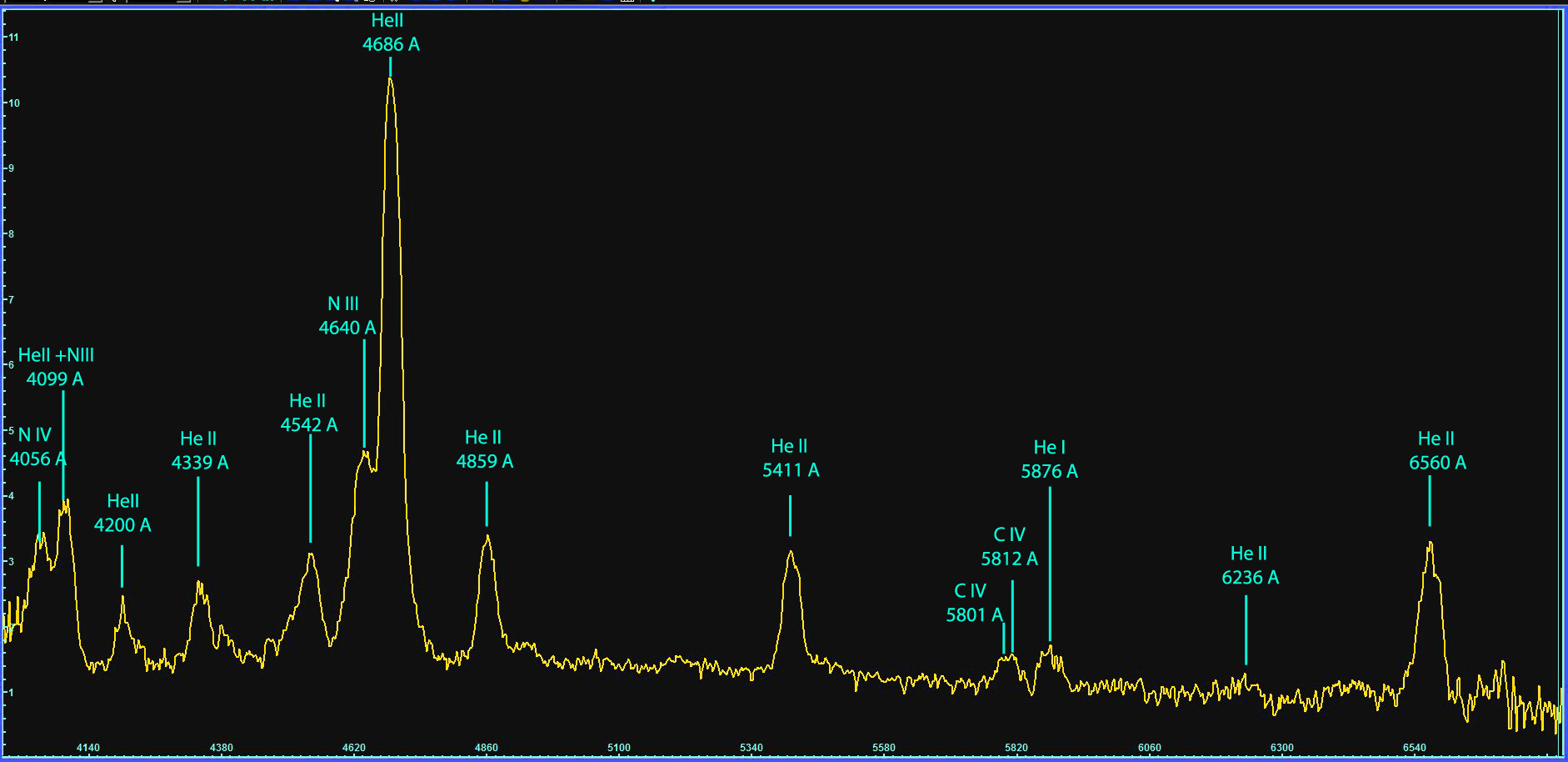
Si tratta comunque di uno
spettro dove le righe dell’Elio ionizzato He II sono talvolta , a bassa
risoluzione, blended con quelle dell Azoto ionizzato N III, come si osserva
nell’immagine che segue, elaborata con
la routine “Lineident” di V Spec.
It’s , any way, of a spectrum were, for the low resolution, the lines of He II
are often blended with those of N III, as you can see in the following profile,
processed with the “lineident” routine of V Spec.
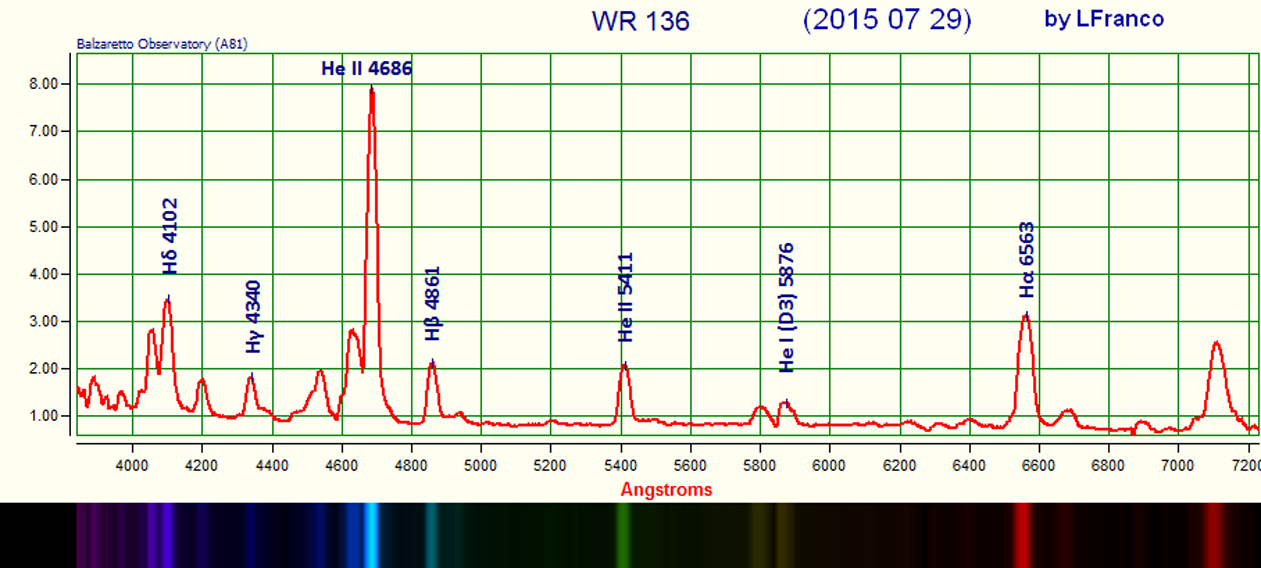
WR 136: Lo spettro di Paolo Corelli con uno spettrografo autocostruito
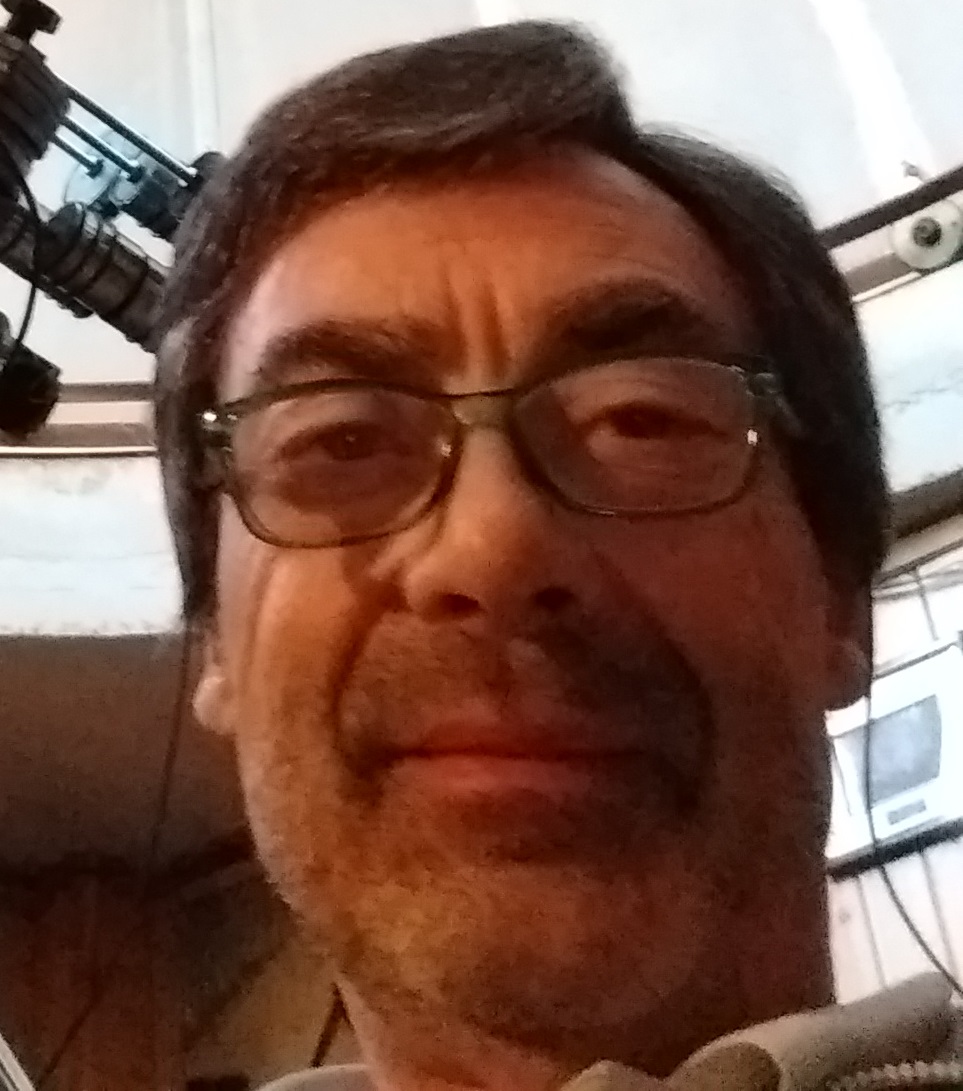
Paolo Corelli si occupa di astronomia da oltre 50 anni, E' fra i fondatori dell'Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia che, nel 2020 compirà 50 anni.Ha realizzato la strumentazione su misura per i suoi studi, dal telescopio allo spettrografo. E' approdato alla spettroscopia una quindicina di anni fa realizzando i primi spettrografi con reticoli economici a trasmissione in plastica per passare poi a quelli a riflessione, in combinazione Littrow. I suoi campi di interesse sono le novae, le comete, le stelle peculiari, binarie spettroscopiche e spettroscopia planetaria.
Paolo Corelli is interested in astronomy since 50
years.He is one of the founders of Friulan Society of Astronomy and Meterology,
he use self built instruments, also in spectroscopy
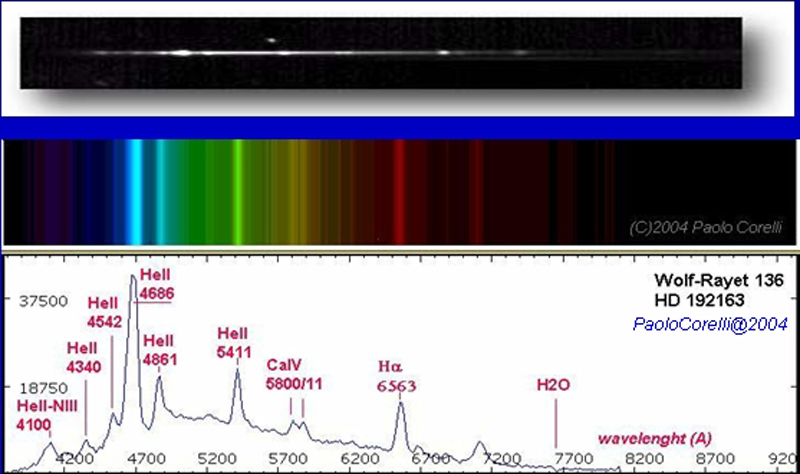
WR 136:
Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo
LHires III
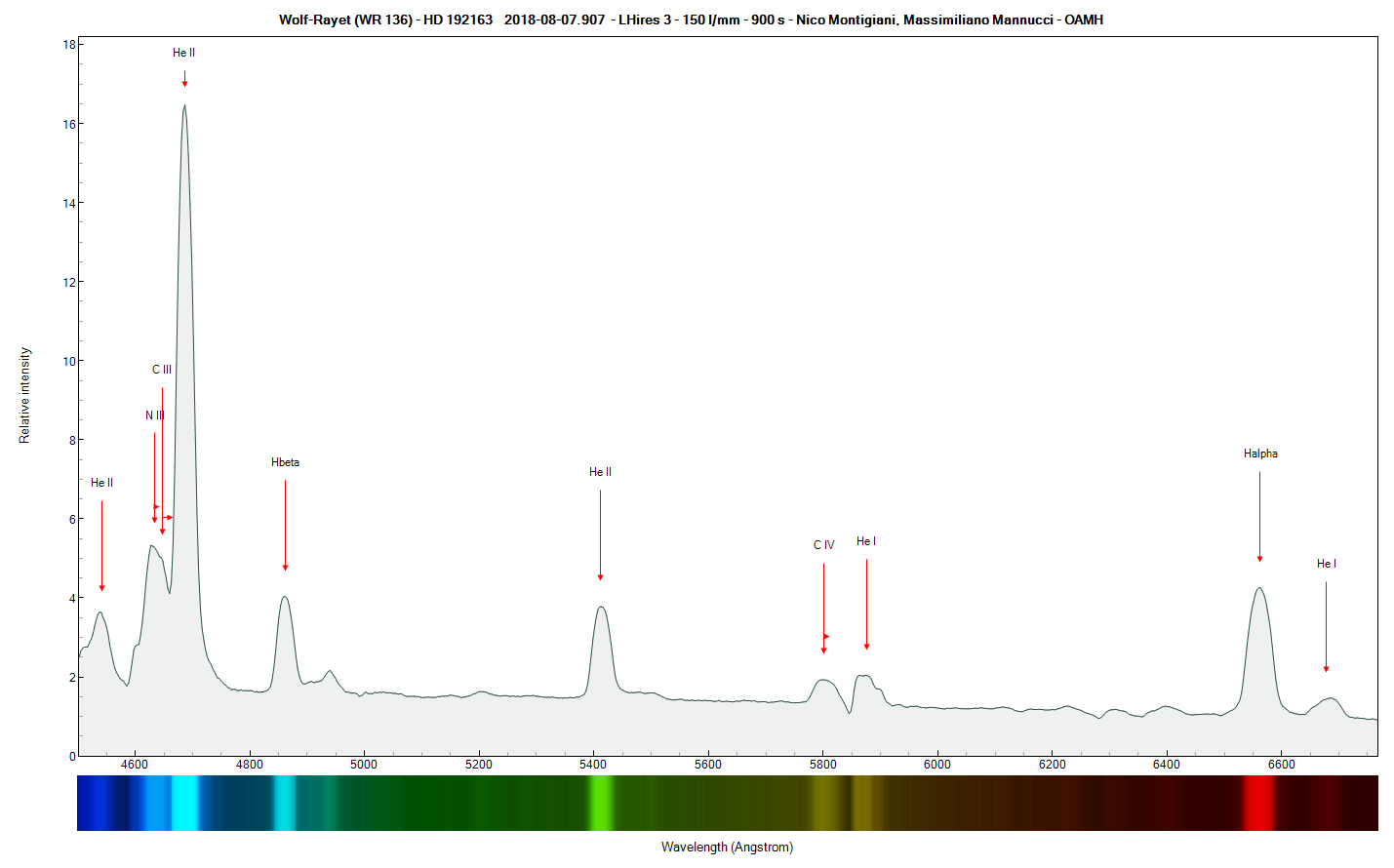
5-WR 137
La WR 137 è una stella variabile distante circa 6000 a.l. dalla terra, nella costellazione del Cigno, di magnitudine apparente 7.9.La WR 137 è parte di un sistema binario con una compagna classe O9.Essa è di classe spettrale WC7, con la presenza delle righe del carbonio ionizzato C III e C IV.
Nell'immagine sottostante, la WR 137 come appariva nel campo della camera di guida Lodestar usata in binning 2x2.
The WR 137 is a variable star distant about 6,000 a.l. from
the earth in the swan constellation of apparent magnitude 7.9. The WR 137 is
part of a binary system with a class O9 companion. It is spectral class WC7 with
the presence of the lines of ionized carbon C III and C IV.
In the image below, the WR 137 as it appeared in the field of the Lodestar
autoguiding camera used in binning 2x2.
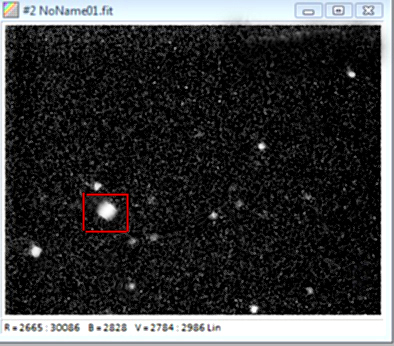
WR 137 Spettro di Fulvio Mete con lo Spec 600
Lo spettro bidimensionale, acquisito con AA3, media di 4 frames da 600 sec l'una.
The two dimensional spectrum, stacking of 4 frames, 600 secs each.
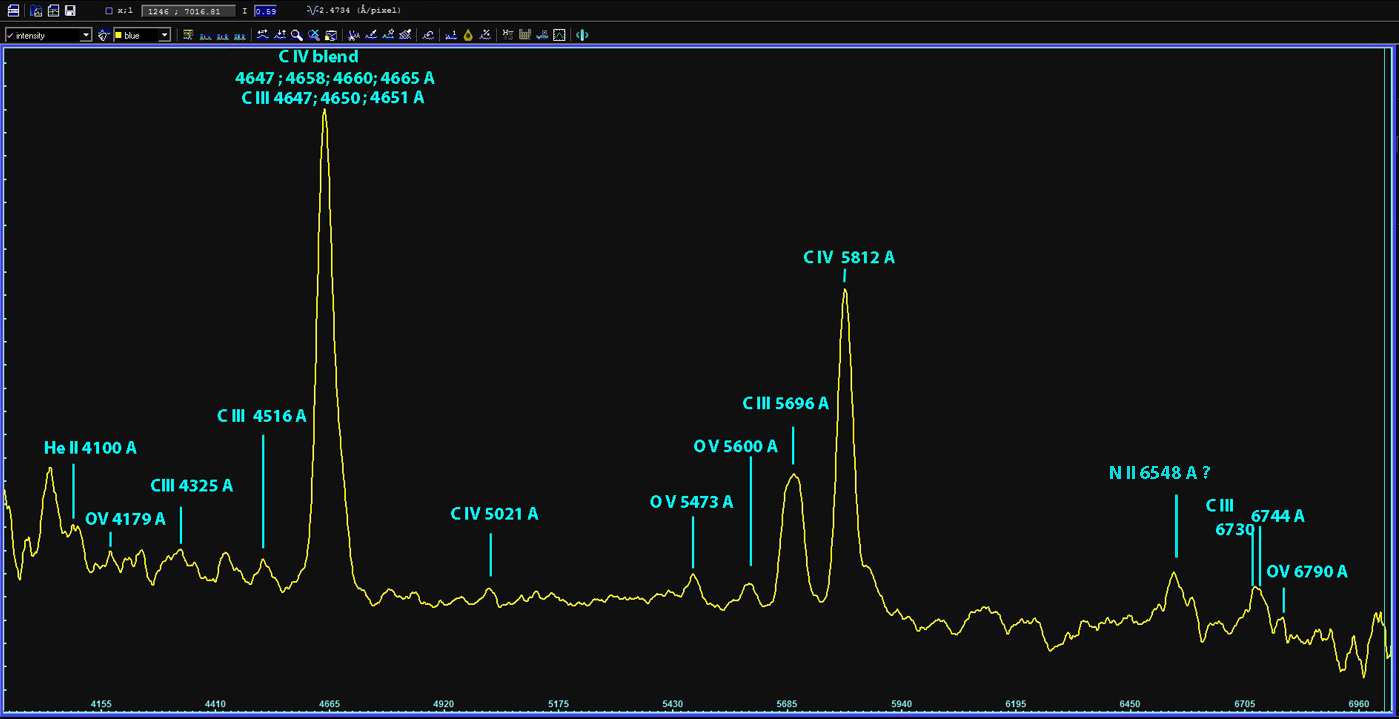
WR 137:
Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo
LHires III
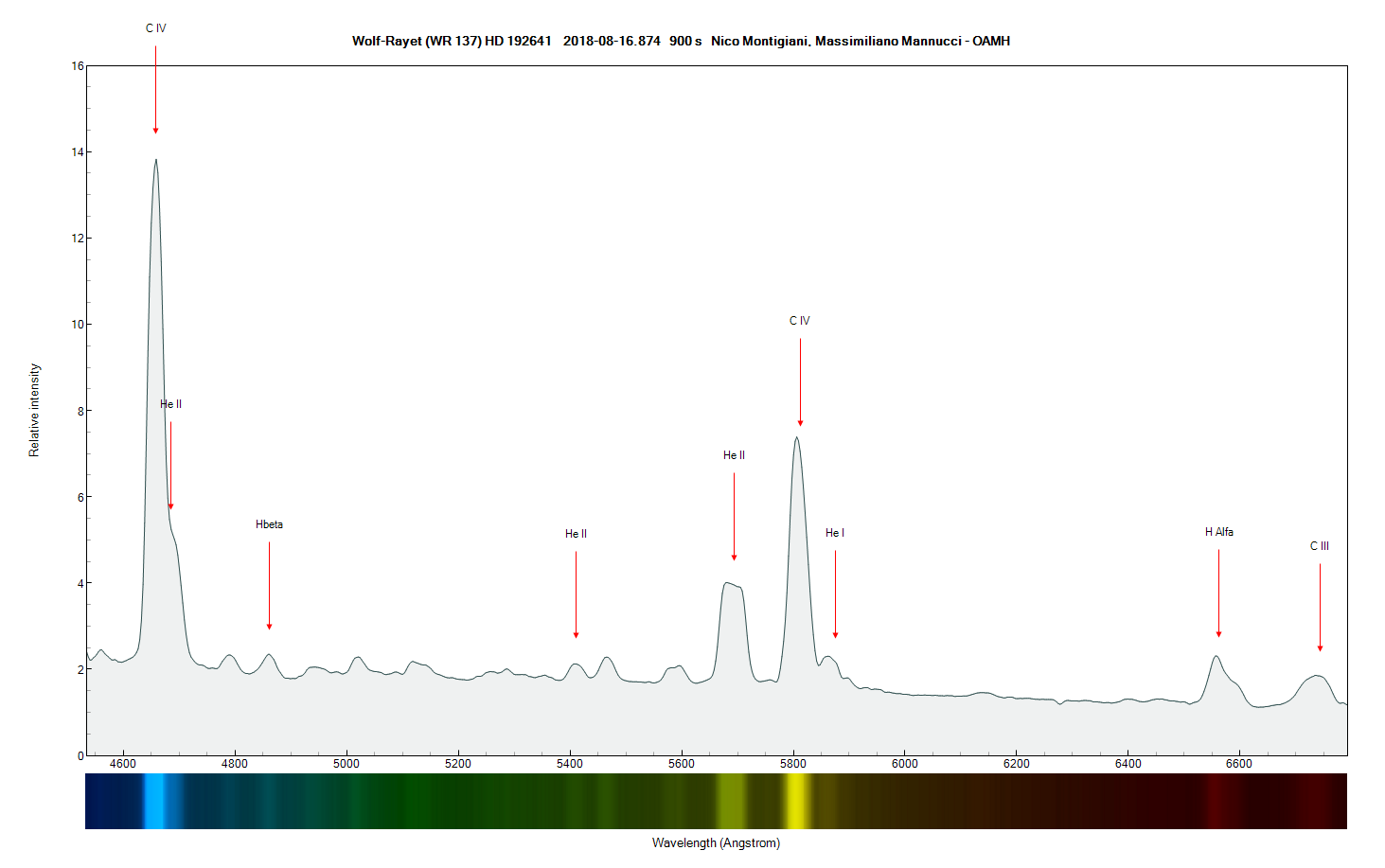
6-WR 138
HD 193077, WR 138, una Wolf Rayet WN 5, di mag 8 facente parte di un sistema con una componente di classe OB, (recenti osservazioni non hanno portato al riconoscimento di una terza componente).La classe WR WN 5 è caratterizzata dall’abbondanza delle righe dell’He II, N III, N IV, mentre sono deboli o assenti le righe della serie di Balmer dell’Idrogeno.La temperatura superficiale è di circa 70.000 K, mentre la velocità del vento stellare, che costituisce una caratteristica delle WR, si aggira sui 1500 Kms.
HD 193077, WR 138, a Wolf Rayet WN 5, of mag 8 belonging to a system with a class OB component, (recent observations have not led to the recognition of a third component). The WR WN 5 class is characterized by abundance of He II, N III, N IV lines, while the lines of the Hydrogen Balmer series are weak or absent. The surface temperature is about 70,000 K, while the stellar wind speed, which is a feature of WR, is around 1500 Kms.
WR 138: Lo spettro di Fulvio Mete con lo Spec 600
Lo
spettro è stato ottenuto con 9 integrazioni da 300 sec nel corso di una breve
vacanza agli Altipiani di Arcinazzo (FR) il 29 giugno 2019 con un Celestron
The spectrum was obtained with 9 300 sec integrations during a brief holiday at the Altipiani di Arcinazzo (FR) on 29 June 2019 with a Celestron 8 af 6.3 on an EQ6 and the Spec 600 slit spectroscope with an Atik 16 HR camera operating in binning 2, Lodestar autoguider. The dispersion was 4.6 A / pixel.
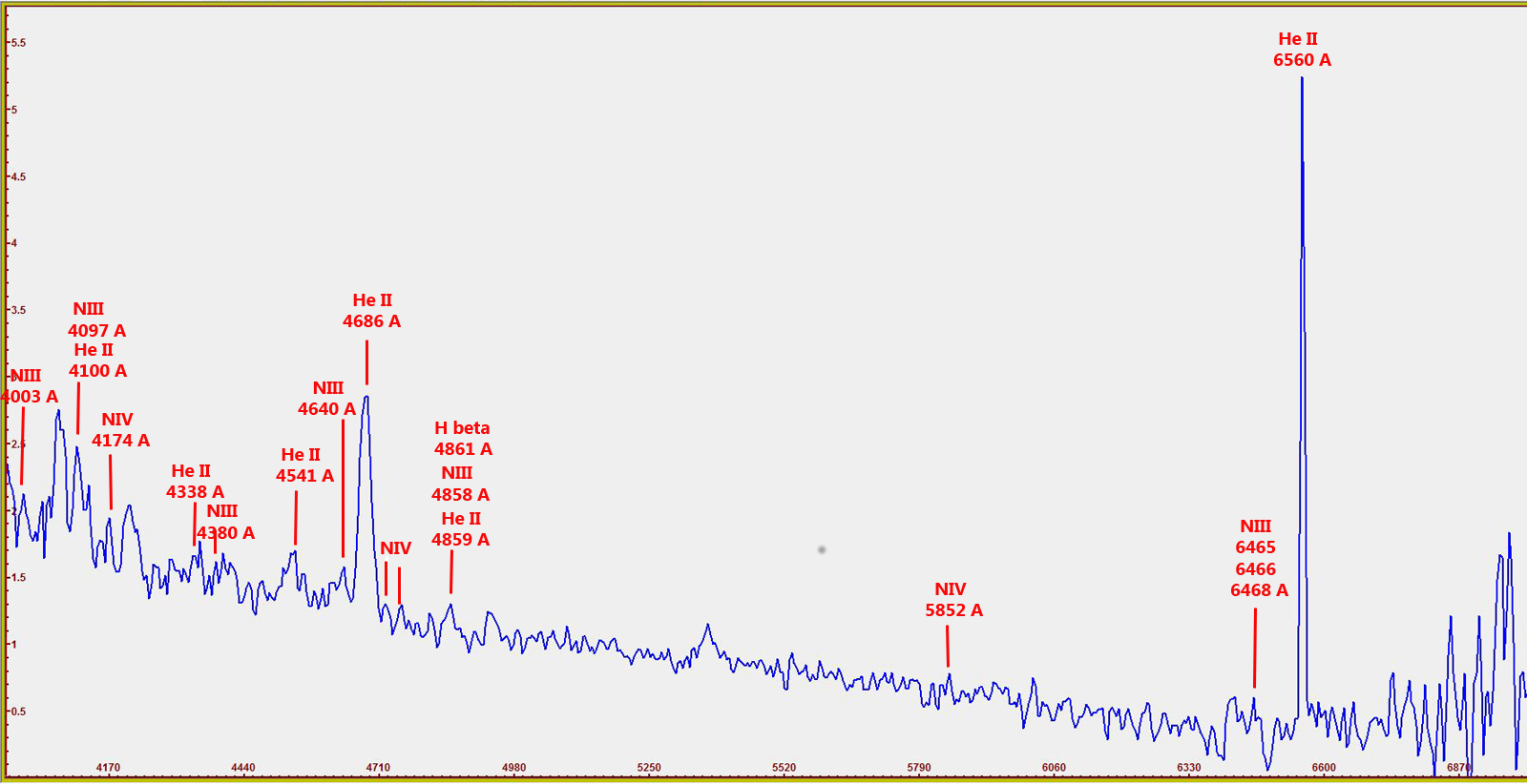
WR 138:
Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo
LHires III
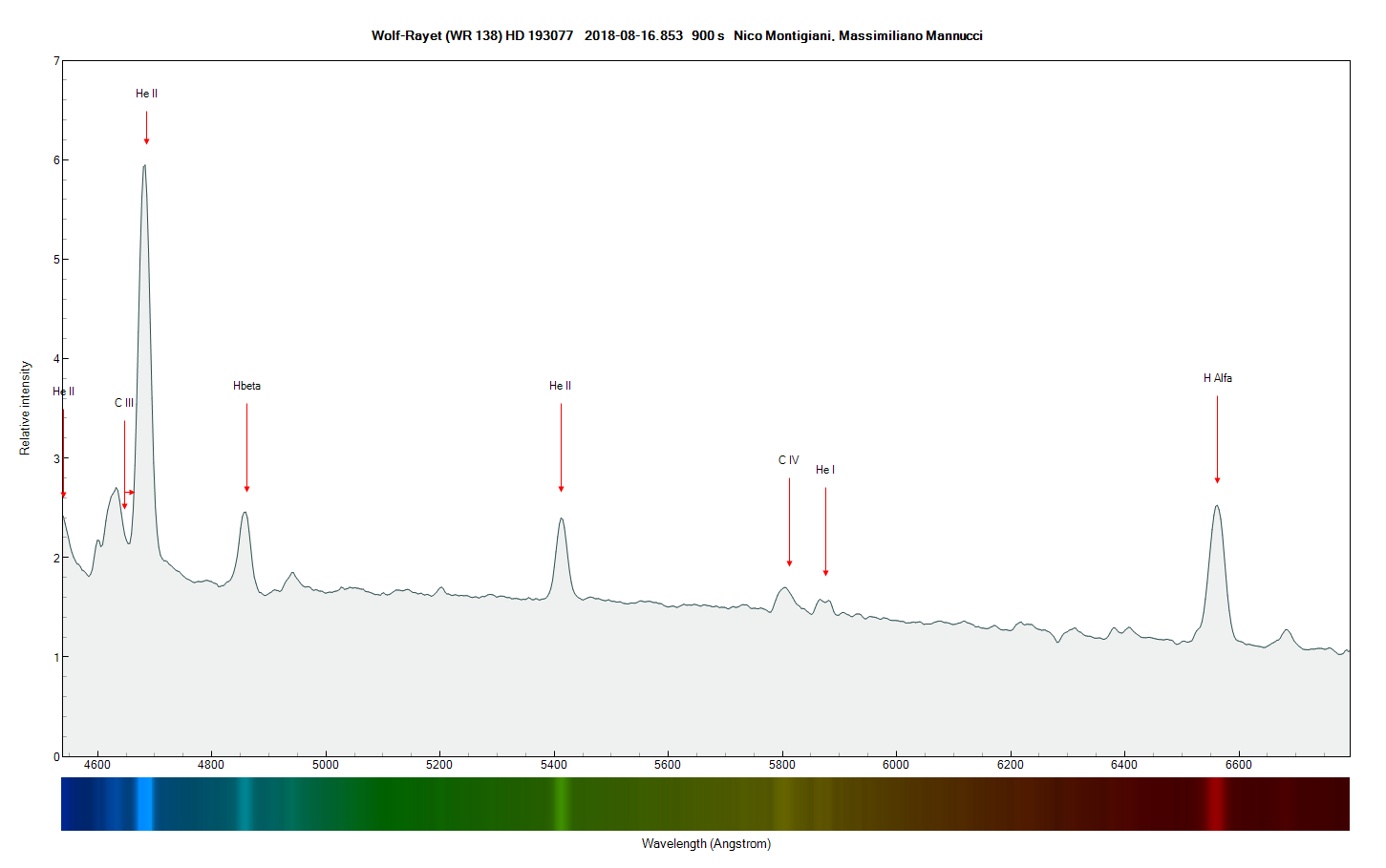
7-WR 139
WR 139- Spettro di Fulvio Mete con lo Spec 600
La Wolf-Rayet 139 (V 444 Cygni) fa parte di un sistema
binario situato nella costellazione
del Cigno ed è costituito da una stella
di Wolf-Rayet
WN5 e da una Stella
di classe O V.I.ll sistema dista
Il sistema si presenta
contemporaneamente come una binaria
spettroscopica e una binaria
a eclisse del tipo
Algol con un periodo
orbitale di 4,2 giorni per le due componenti, che distano
tra loro circa 0,38 UA.
La componente principale è la stella di classe O, avente una massa 25
volte superiore a quella del Sole,
mentre la stella di Wolf-Rayet, 10 volte più massiccia della nostra stella, ha
una temperatura
superficiale di oltre 80.000 K,e
perde massa al ritmo di 0,6 × 10-6 M all'anno.
Data la relativa vicinanza tra le due componenti, lo scontro dei rispettivi venti
stellari provoca un'intensa emissione di raggi
X e radiazione UV.
The Wolf-Rayet 139 (V 444
Cygni) is part of a binary system located in the constellation of the Swan and
consists of a star of Wolf-Rayet WN5 and a Star of class O VIll system is
2077.47 al from the ground (Hipparcos data 2007). His magnitude ranges from
8,033 to 8,379.
The system is presented at the same time as a binary spectroscopy and an
eclipsing binary of the Algol type with an orbital period of 4.2 days for the
two components, which are about 0.38 AU apart from each other. The main
component is the class O star, having a mass 25 times greater than that of the
Sun, while the star of Wolf-Rayet, 10 times more massive than our star, has a
surface temperature of over 80,000 K, and loses mass at rhythm of 0.6 × 10-6 M
per year. Given the relative proximity between the two components, the collision
of the respective stellar winds causes an intense emission of X rays and UV
radiation.
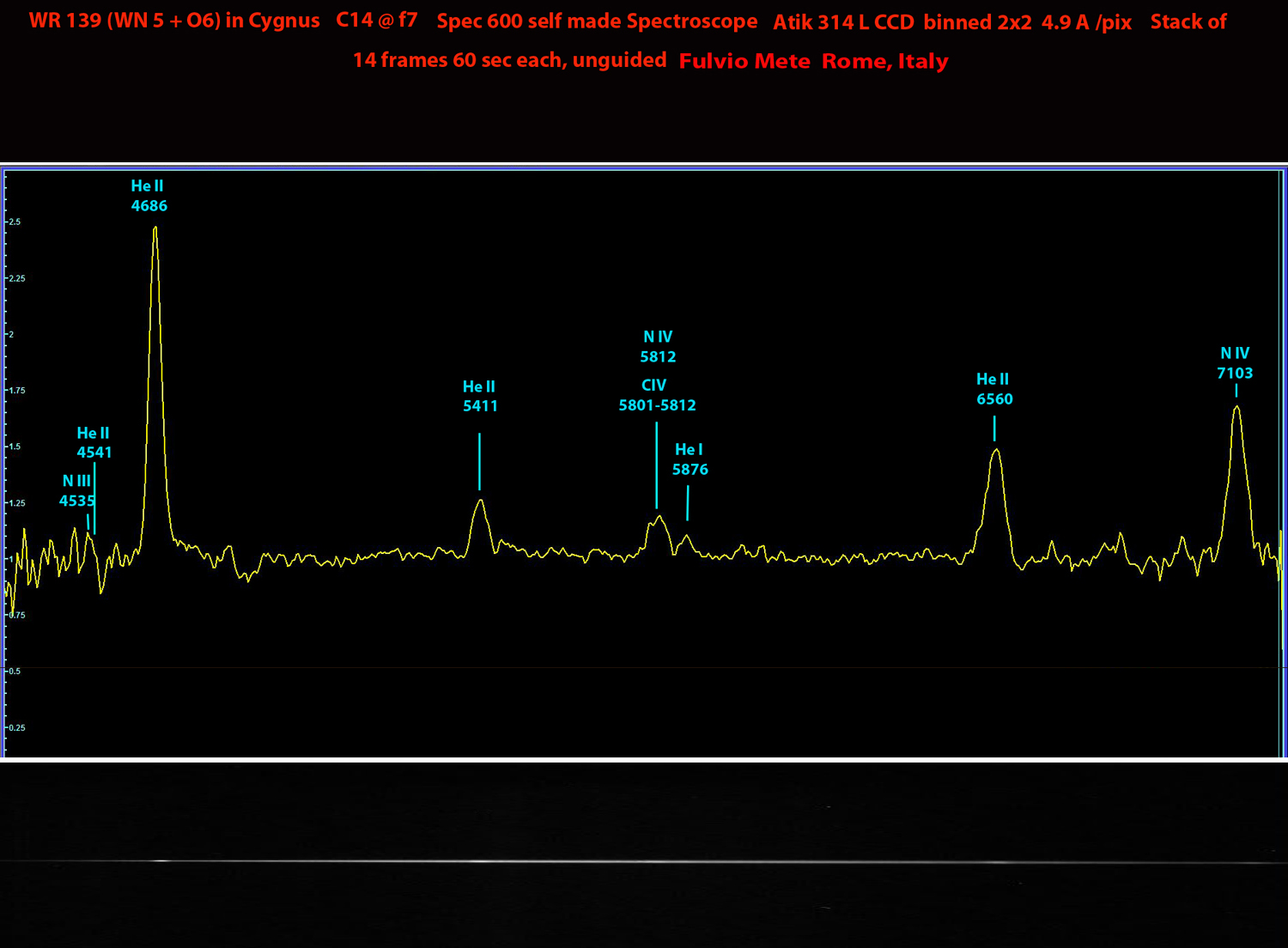
WR 139:
Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo
LHires III
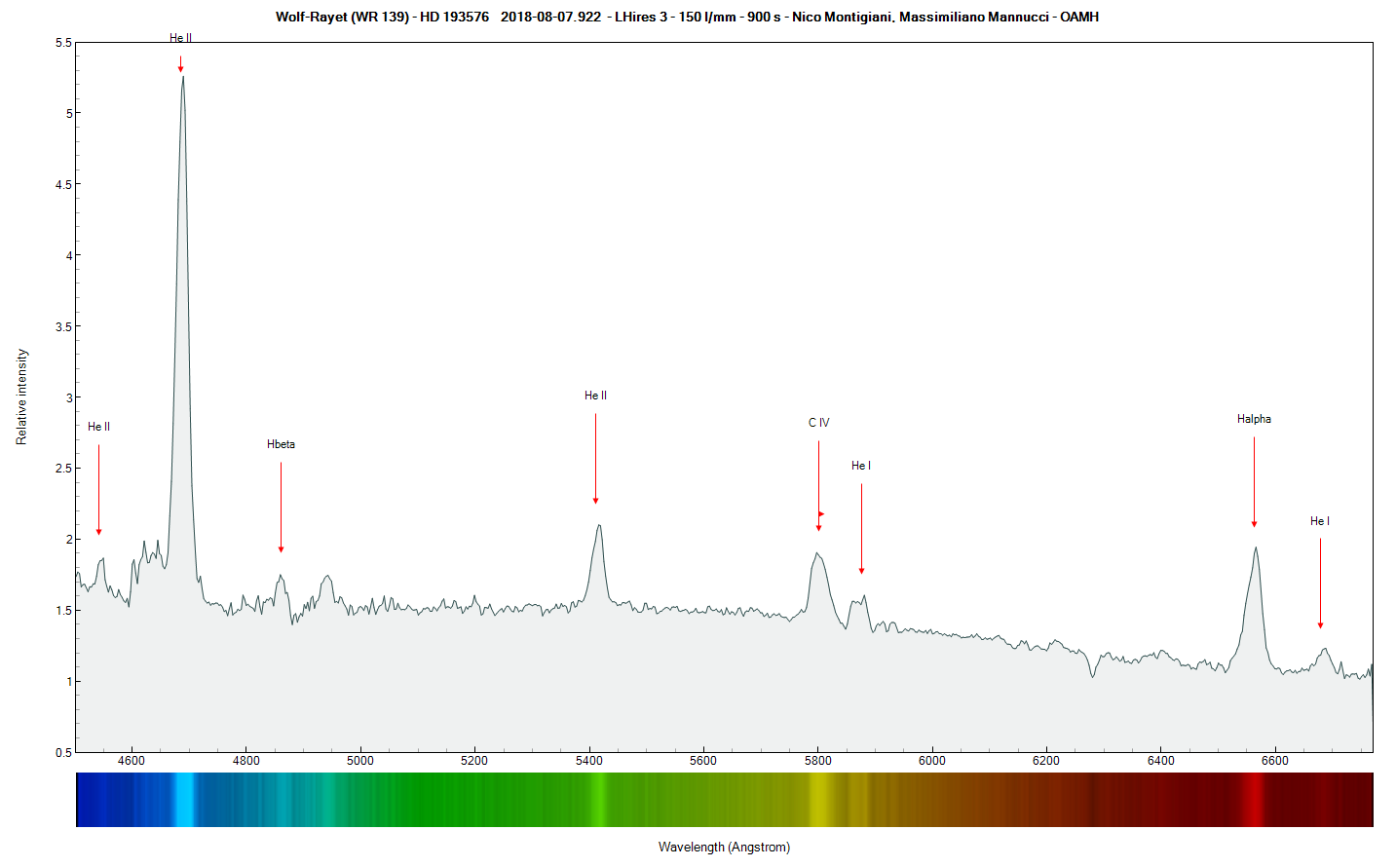
8-WR 140
WR
140: Lo spettro di Lorenzo Franco con uno spettrografo Alpy 600
Here is a spectrum
of the WR 140 taken on July 29, 2015 by Lorenzo Franco,in Rome , with an Alpy
600 Spectrograph at the focus of a Meade
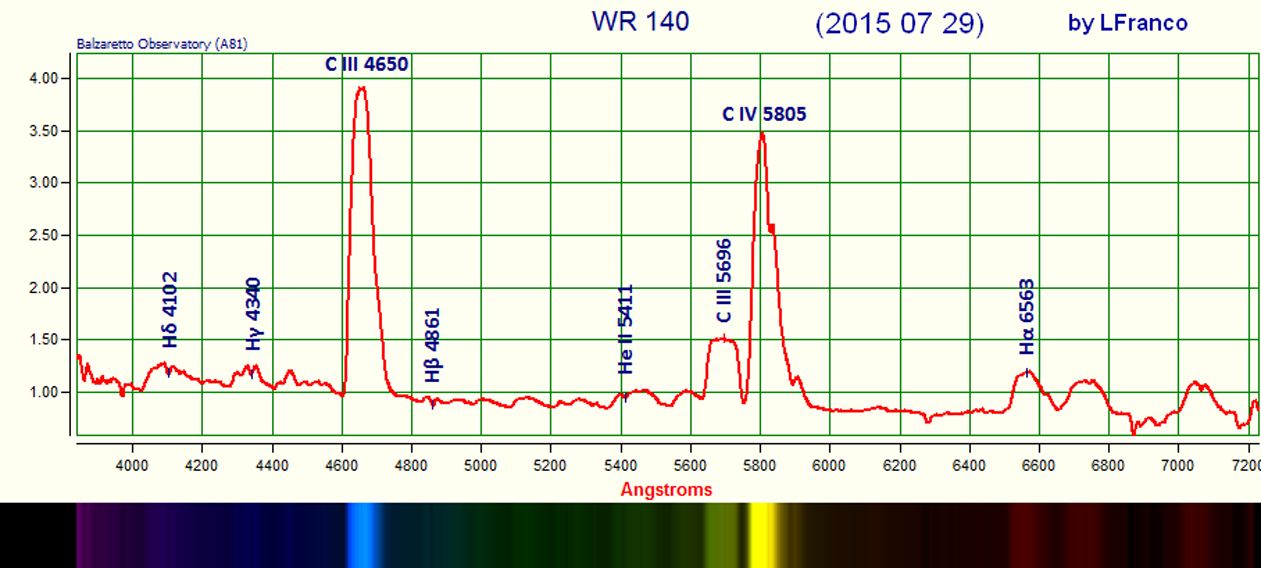
WR 140: Lo spettro di Paolo Corelli con uno spettrografo autocostruito
Lo spettro di Paolo Corelli ripreso il 9.11 2011
The spectrum of Paolo corelli, taken on november, 11, 2011
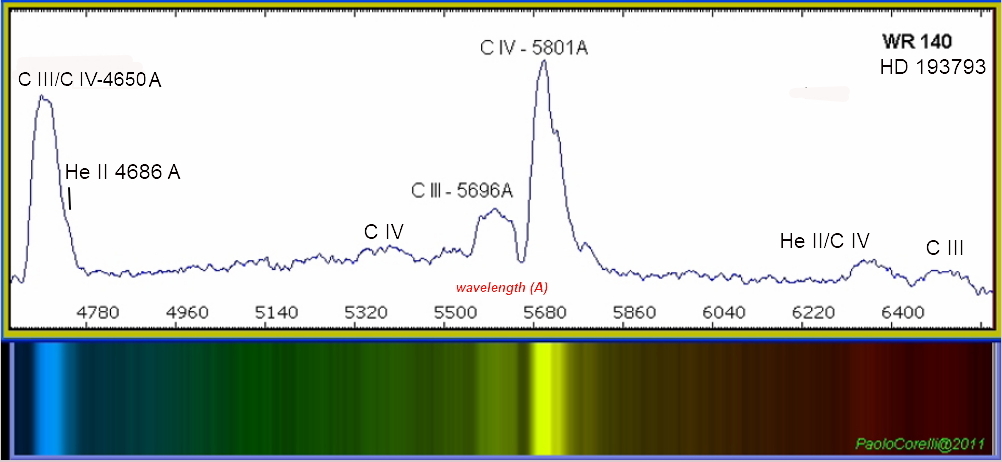
WR 140: Lo spettro di Fulvio Mete con lo Spec 600
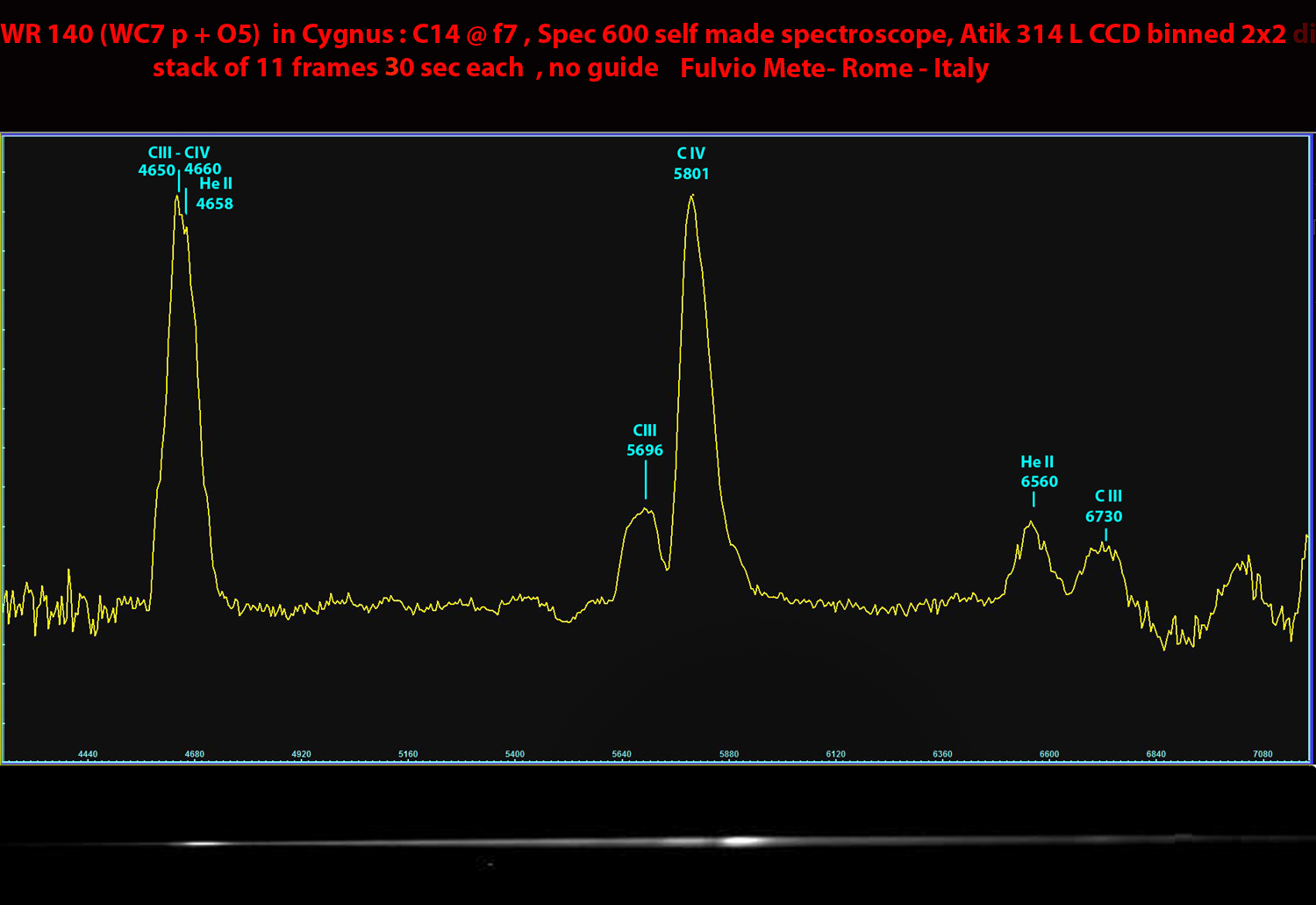
_5_._,__(_#_% _!___D_2]__OK_&_$___ _!___._$_!___/__!OK_F_!_>___;2-¨6.__:/@_%
2__/98__.__OK_______D__12__Q®
WR 140:
Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo
LHires III
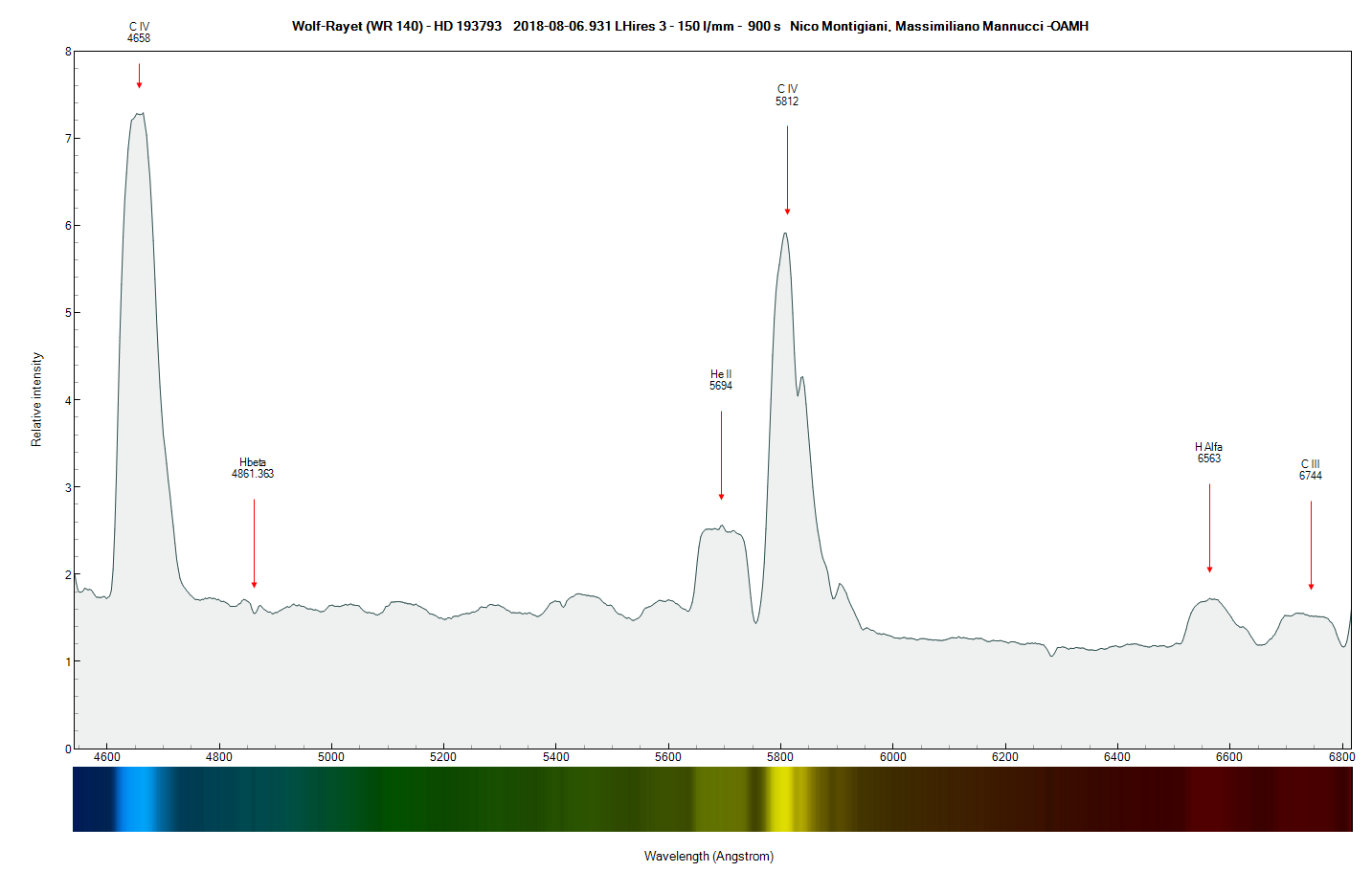
9-WR 141
WR 141:
Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo
LHires III
La Wolf-Rayet WR 141 (WN6), HD 193928: ,
riclassificata come OB WN5o da Smith, Shara e Moffat 1996, dove "o"
rappresenta una quantità non rilevabile di idrogeno (cioè H / He <0,5 in numero) è
una binaria spettroscopica nella quale l'altro componente è una stella di classe
O5 V.La magnitudine apparente è 9.78 (v)
Wolf-Rayet WR 141 (WN6), HD 193928:, reclassified as WN5o by Smith, Shara and Moffat 1996, where "o" does represent a not detectable amount of hydrogen (ie H / He <0.5, in number ) it's a. spectroscopic binary in which the other component is a star of class O5 V.The apparent magnitude is 9.78 (v).
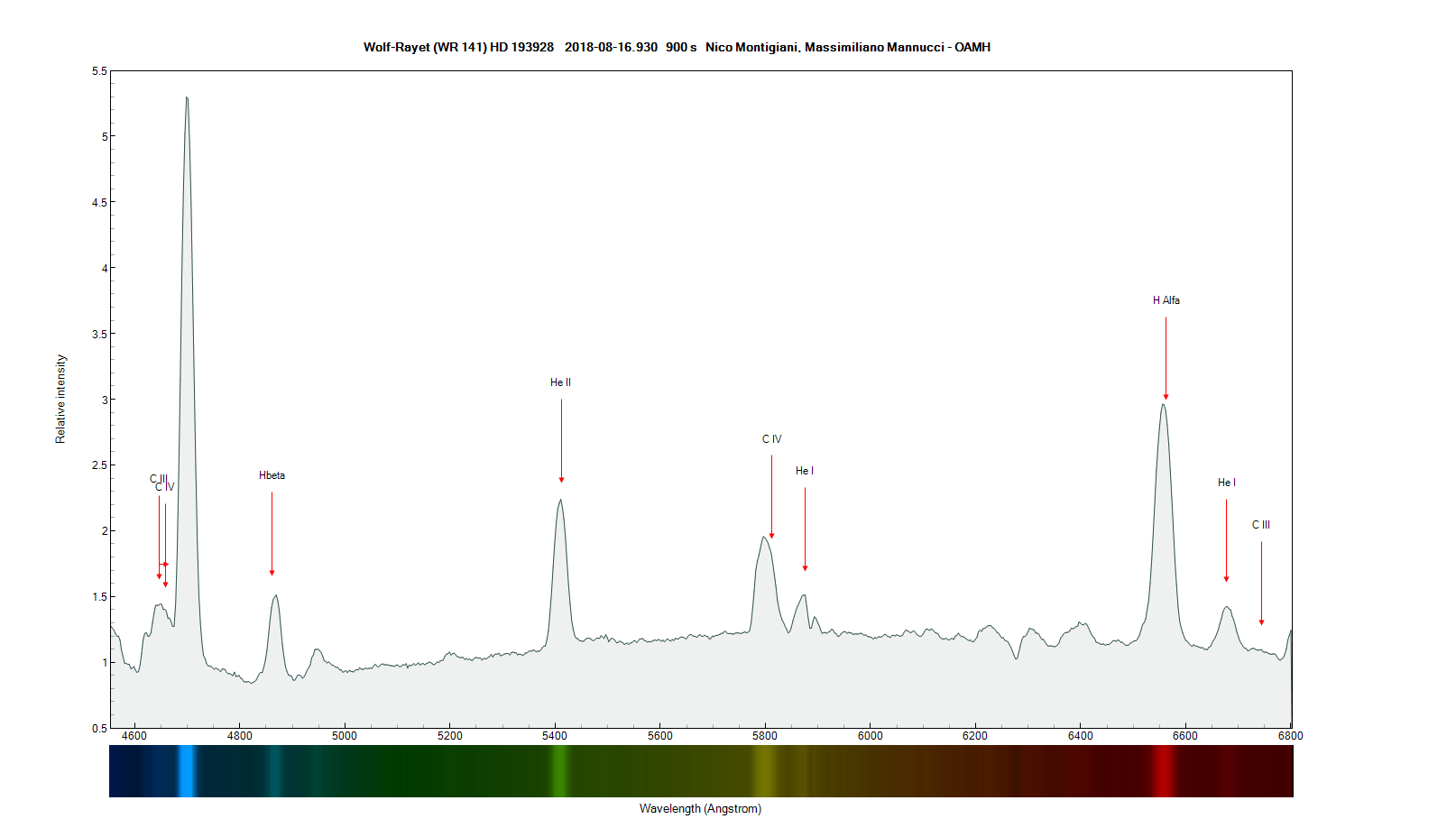
10-WR 153
WR 153:
Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo
LHires III
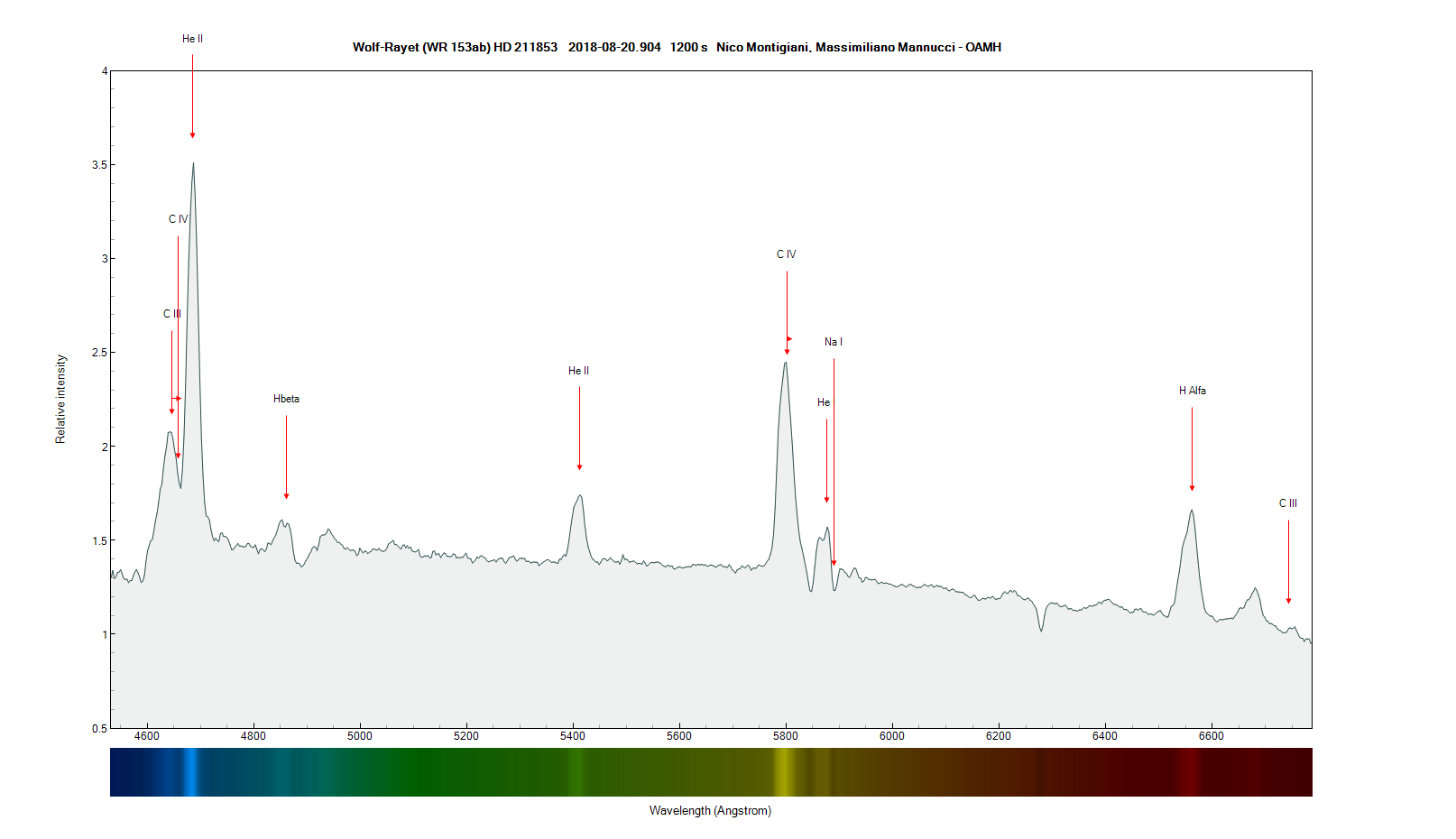
11-WR 155
WR 155: Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo LHires III
La WR 155 è un sistema binario ad eclisse costituito da una WN 6 e da una stella di classe O 9 II-Ib, di mag. 8.8 (v)
WR 155 (CQ Cep, HD 214419) is a WN 6+O9 II-Ib stars eclipsing binary , mag (V) 8.8.
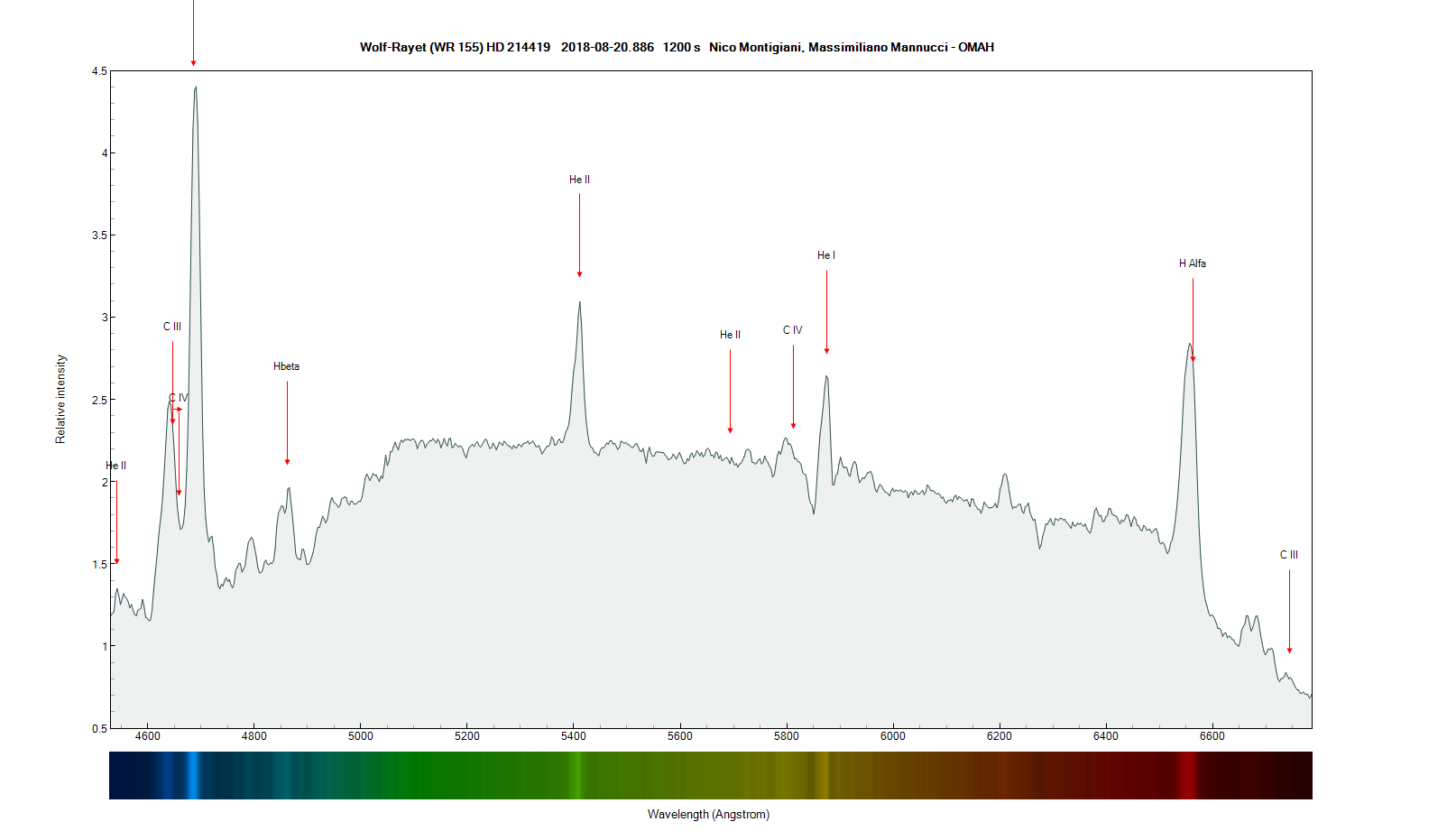
12-WR 157
WR 157:
Lo spettro di Massimiliano Mannucci e Nico Montigiani con uno spettrografo
LHires III
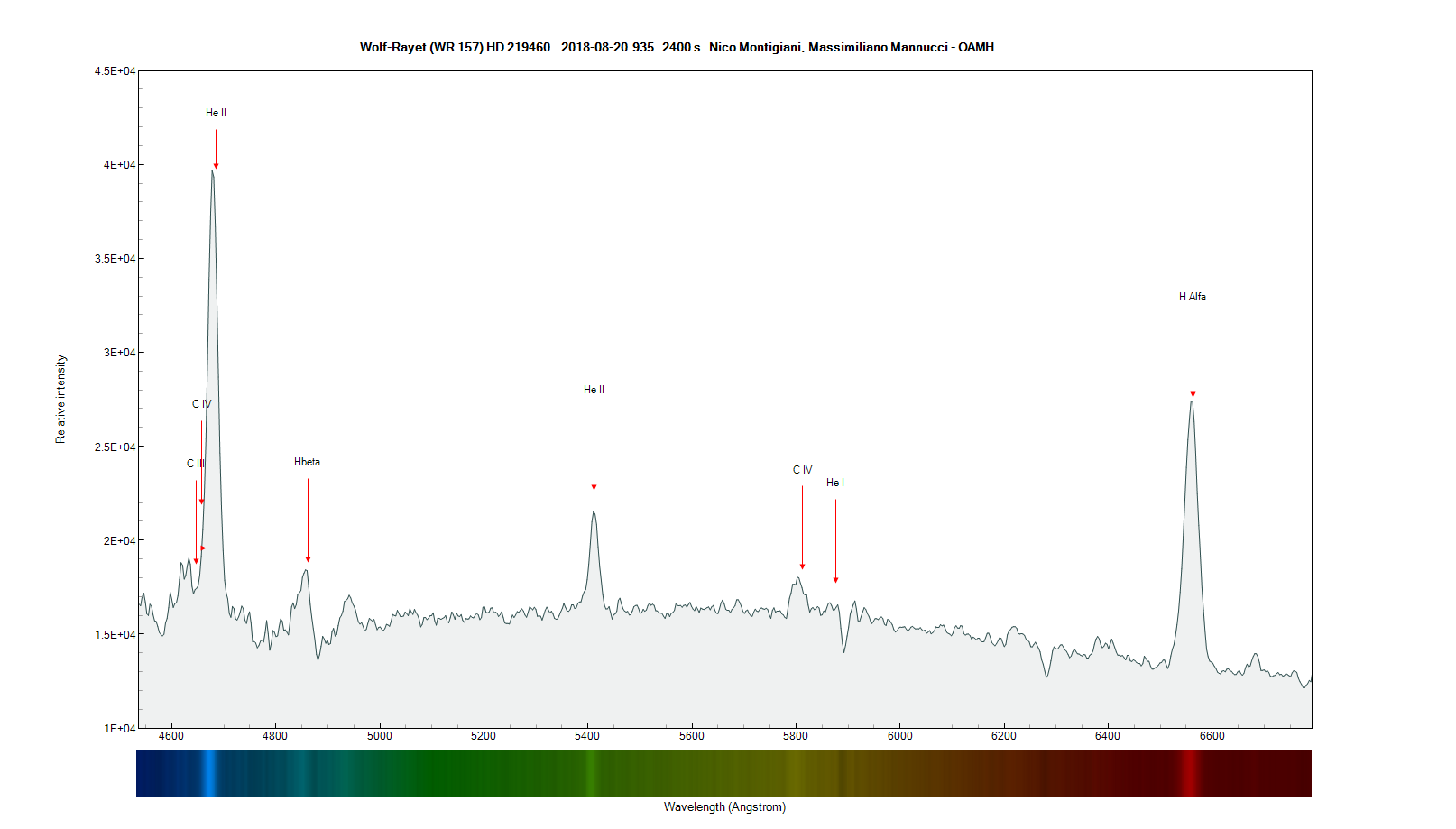
13-NGC 40
NGC 40: Lo spettro di Fulvio Mete
Ngc 40 è una
nebulosa planetaria nella costellazione del Cefeo, lontana circa 4000 al dalla
terra. La sua caratteristica peculiare è che la stella centrale ,HD 826, di mag
11.6
e 0.7 masse solari,presenta una temperatura molto
elevata, circa 90000 K e forti venti stellari (ca 1800 Kms), in modo da poterla
considerare una stella di Wolf Rayet ( tipo WC 8, carbon star)
anziché
una nana bianca, comune a gran parte di tali nebulose.Il livello di ionizzazione
della nebulosa , inferiore a quello che dovrebbe essere per la caratteristica
della stella centrale, suggerisce la presenza di uno scudo di materia, polveri e
gas, tra la stessa e la stella centrale.Nell’immagine che segue (fonte NOAO –
WIYN 3.5 mt telescope) un’immagine RGB in alta risoluzione della planetaria ,
che sottende soltanto 38 x
![[NGC40]](Spectroscopy%20Images/clip_image001.jpg)
Lo spettro di
tale oggetto si presenta complesso, dovendosi distinguere tra quello della
stella centrale e della nebulosa, con caratteristiche molto differenti.
La sera del 5
settembre scorso ho voluto tentare
la ripresa CCD dell’oggetto in questione ,
utilizzando la raccolta di luce del mio C14 ed il solito ed efficientissimo
spettrografo autocostruito Spec 600 (camera Atik 16 HR).Si trattava tuttavia di
riprendere due diverse zone della nebulosa.Per evitare ciò ho usato una
fenditura molto aperta anche per la focale di
Ecco come si
presentava la nebulosa alla camera di guida Lodestar (5 sec):

Una volta
fatto lo stacking delle riprese, dovevo
tuttavia separare i due spettri, evidenti
nell’immagine finale.
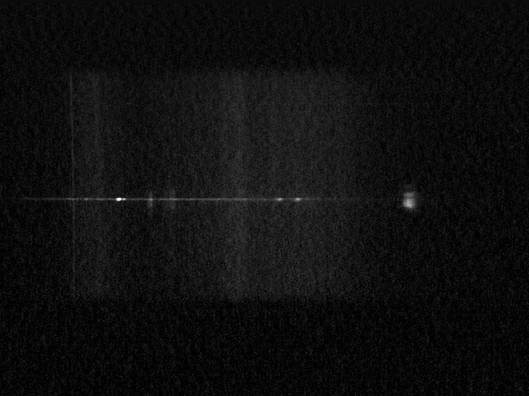
Ho quindi
ricavato un primo profilo della stella centrale
con un binning sulla stella
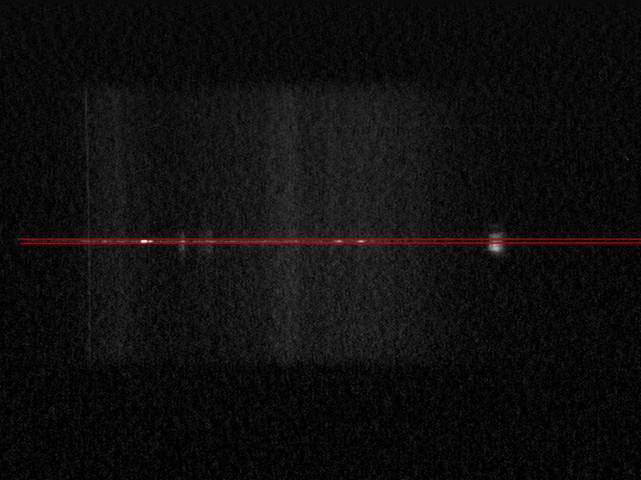
E quindi un secondo sulla parte dello spettro con la nebulosa.
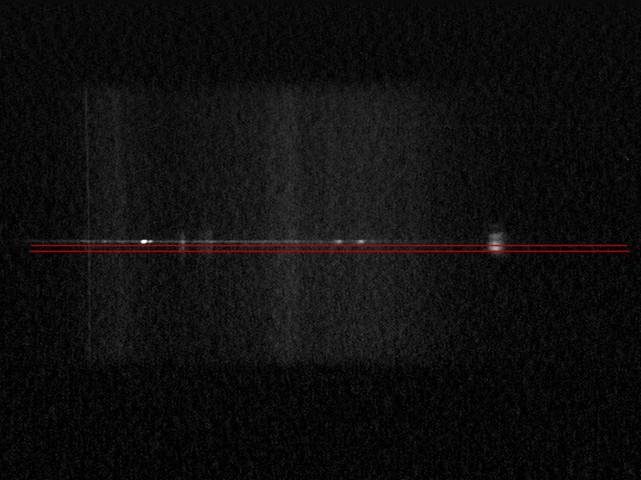
Da qui i rispettivi profili spettrali ottenuti con Visual Spec:
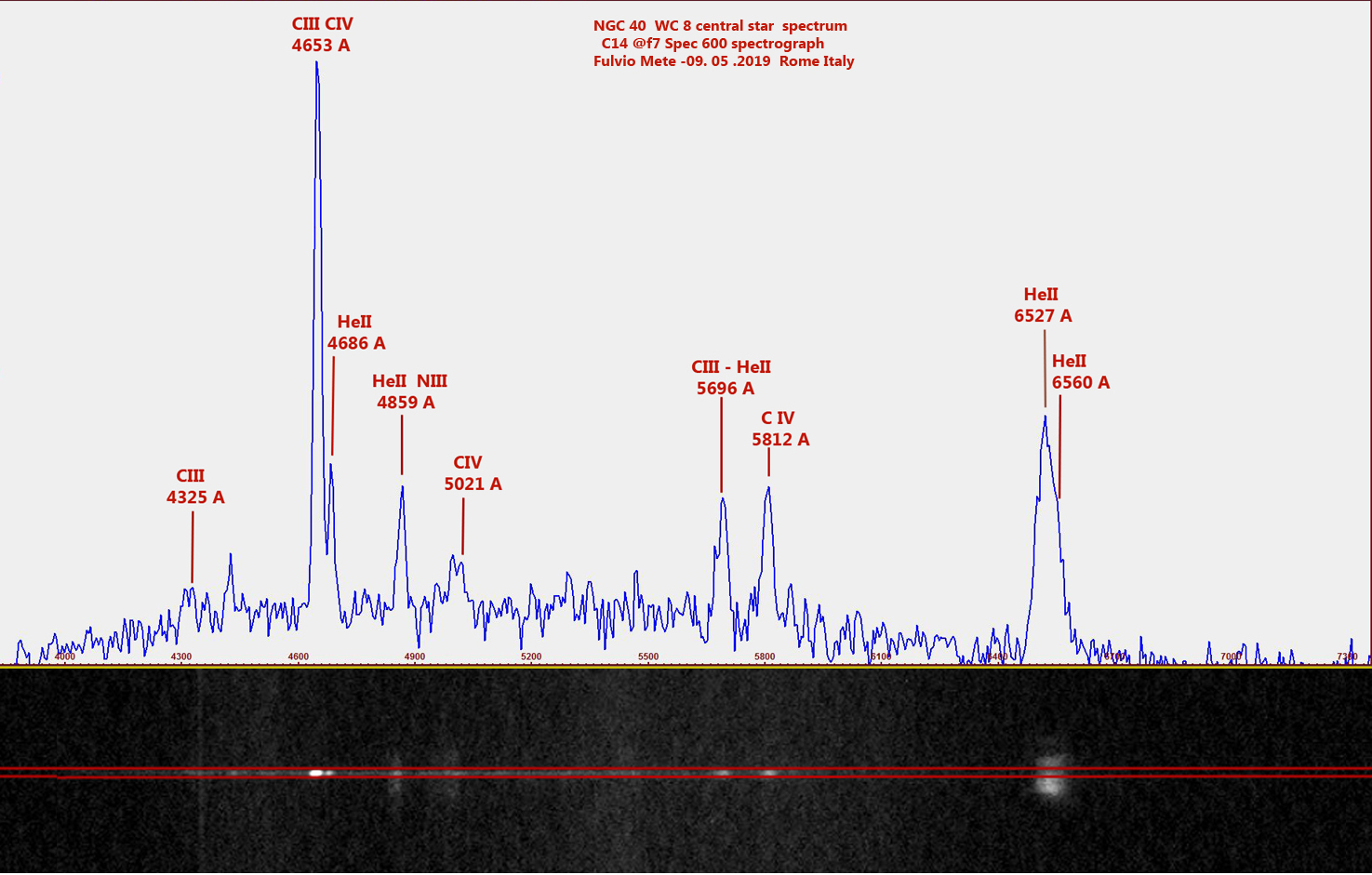
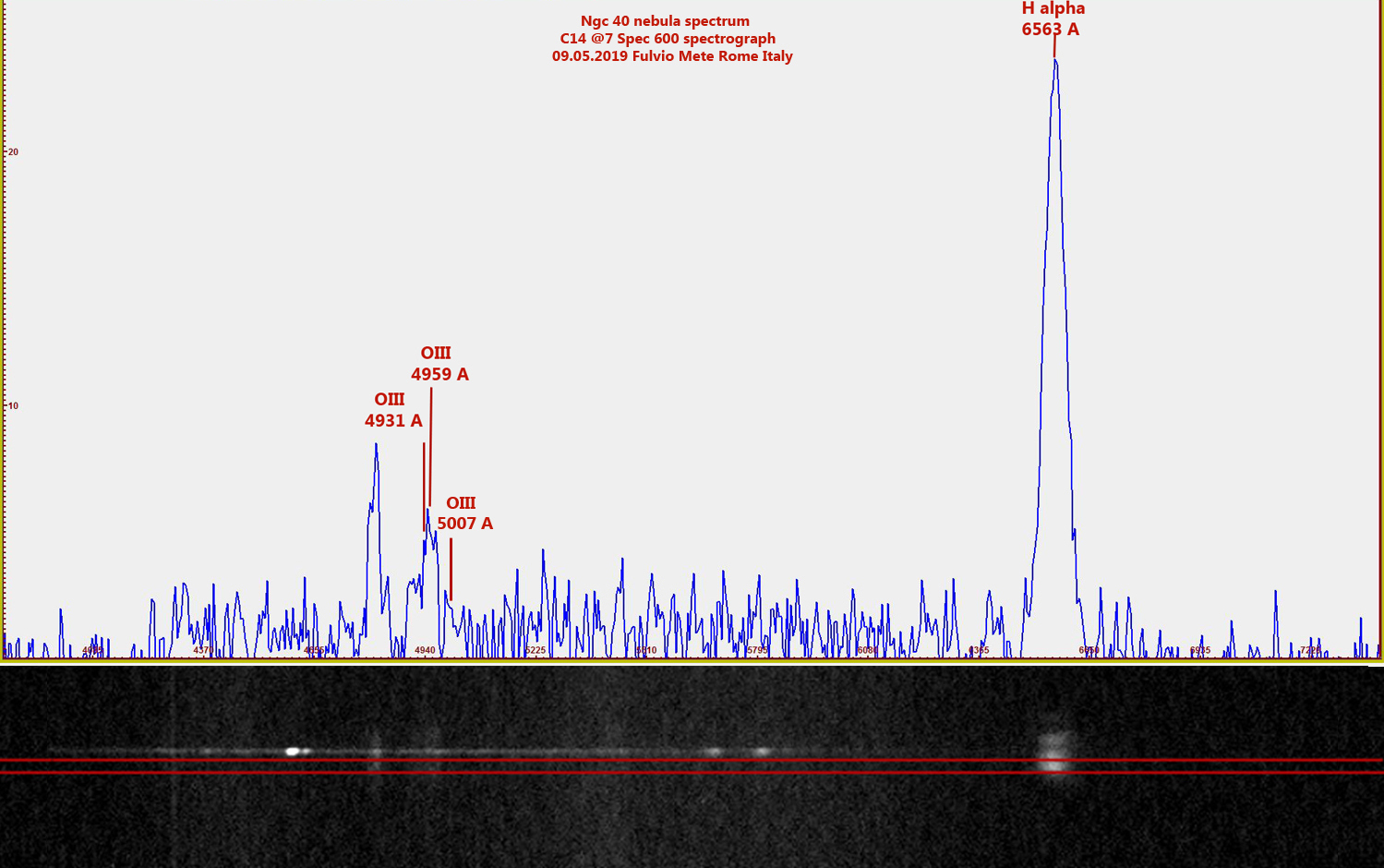
Fulvio Mete -Roma 2.12.2017
Osservazione amatoriale della struttura di ionizzazione di Messier 42 nelle zone
est-ovest rispetto al trapezio
Le nebulose ad
emissione, com’è noto, sono formate da gas caldo che emette radiazione,
riscaldato dall’emissione ultravioletta di una o più stelle, oppure dal processo
di radiazione di sincrotrone.La nebulosa di Orione, Messier
42, è una delle più note e fotografate nebulose ad emissione, la
regione HII di formazione stellare più nota ed osservata, e la sola osservabile
ad occhio nudo.Essa si trova a circa 1600 a.l. da noi ed il gruppo centrale di
stelle, cd “ammasso del Trapezio” è responsabile della ionizzazione della
nebulosa.All’interno della stessa sono presenti anche alcuni oggetti Herbig-Haro
(HH) , che si formano quando getti di gas ionizzato provenienti da stelle in
formazione collide con nubi di gas e polveri più dense a velocità elevate,e
l’onda d’urto eccita gli atomi del gas che si illumina per
elettroluminescenza.Il colore prevalentemente rosso della nebulosa è associato
all’emissione dell’Idrogeno ionizzato alla lunghezza d’onda di 6563 A, ma si
osservano anche altri elementi, nelle righe proibite dell’Ossigeno, azoto e
zolfo (tali righe si dicono proibite in quanto non riproducibili in
laboratorio).
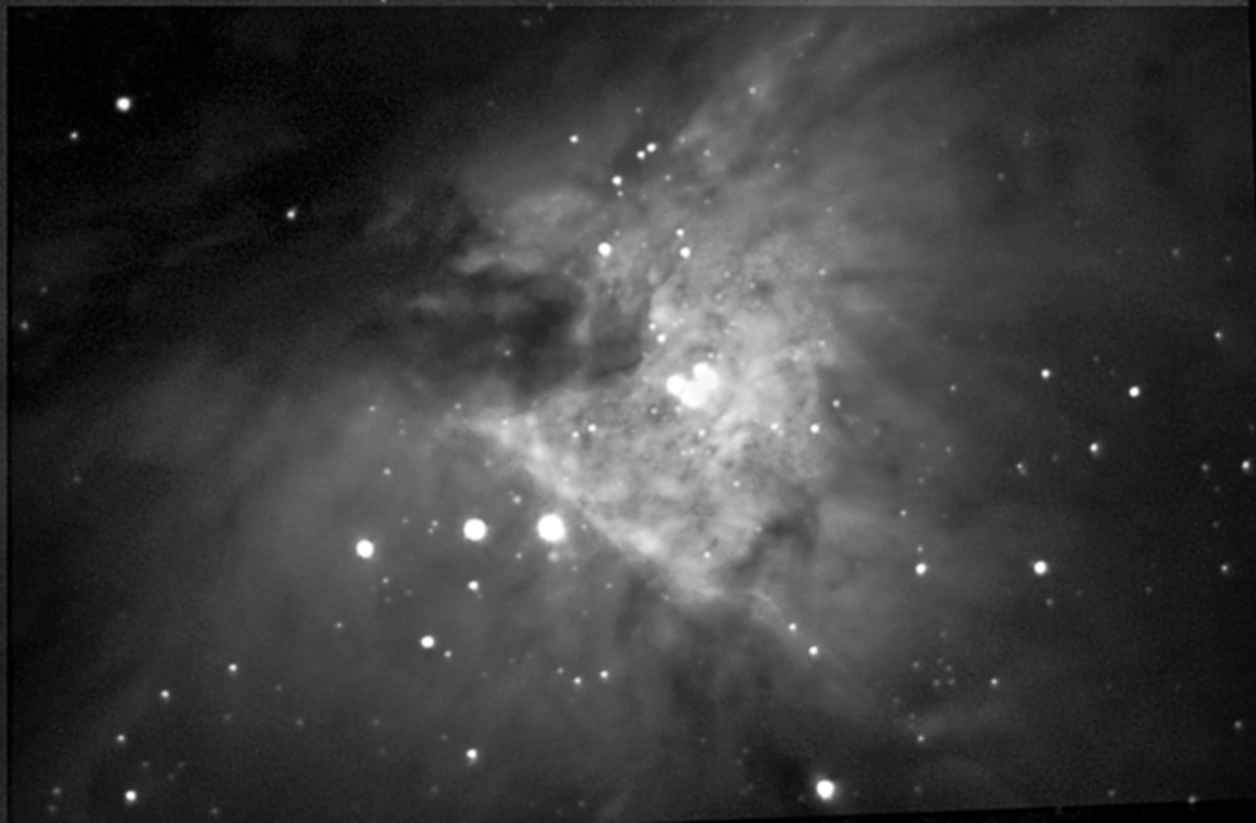
Un’immagine
CCD della parte centrale di M 42.Foto dell’autore con un Celestron
14.L’immagine, ottenuta con l’apporto di una componente IR, mostra molte stelle
intorno a quelle del trapezio, normalmente coperte dalle nubi di gas e polveri.
La nebulosa ha costituito per decadi un laboratorio per lo
studio dei processi di formazione stellare e di ionizzazione.
Si presenta qui uno studio amatoriale di spettroscopia a
bassa risoluzione (R= 600 max, disp. 2.5 A/pixel) per un range di lunghezze
d’onda 3900-6800 circa, avvalendosi di uno spettroscopio a fenditura, Spec 600,
auto costruito dall’autore intorno ad un grism da 600 l/mm, e recentemente
(ottobre 2017) upgradato con un nuovo collimatore (vedi immagini seguenti).
Lo strumento è stato usato su un telescopio Schmidt
Cassegrain Celestron 8 di primissima serie (marzo 1970) di focale ridotta ad f
6.3 su una montatura Losmandy G11, dal terrazzo di casa di chi scrive, in
Roma.La camera usata è stata una Atik 16 HR (sensore Sony ICX 285 AL) in binning
1x1.
La fenditura è stata aperta a 40 micron, anche a prezzo
di una minore risoluzione, per acquisire la massima parte del flusso luminoso in
zone della nebulosa alquanto scure, considerato anche che dalla postazione
casalinga di chi scrive
l’arco di cielo visibile a sud sottende solo una piccola fetta di
cielo ed il tempo disponibile per la messa a punto della strumentazione e la
ripresa non superava i 40 minuti complessivi.

Il setup usato, descritto in precedenza
Gli spettri bidimensionali sono stati acquisiti con 4 frames
da 300 secs nei giorni 17, 19 e 20 novembre 2017, avendo cura di porre la
fenditura intorno alle stelle del trapezio , ma non sovrapposte a queste come
nelle immagini di seguito mostrate, per verificare il livello di
fotoionizzazione provocato dalle predette stelle, ed per la massima parte da
Theta 1 Ori C (classe O).
La riduzione dei dati derivanti dalle immagini e
l’ottenimento dei profili spettrali è stata effettuata col software BASS e
Visual Spec.
Le principali righe osservate sono state:
NeIII
3967
OII
3973
HeI
4007
H delta
4102
H gamma
4340
OIII
4363
H beta
4861
OIII
4959
blend
OIII
5007
blend
H alpha
6563
NII
6583
blend
NII
6610
blend
La modesta risoluzione dello strumento e la bassa intensità
luminosa dovuto alle polveri e gas del mezzo interstellare lontano dal trapezio
non ha permesso di risolvere appieno alcune righe che risultano in blend con
quelle vicine.
La localizzazione della fenditura sulla nebulosa alle date di
osservazione, rilevata attraverso l’immagine della camera di guida, è stata la
seguente, in un range di circa 20’ a destra e sinistra del trapezio e della sua
stella più luminosa, Theta 1 orionis C, nella regione che più risente del
processo di fotoionizzazione indotto dalla stella:
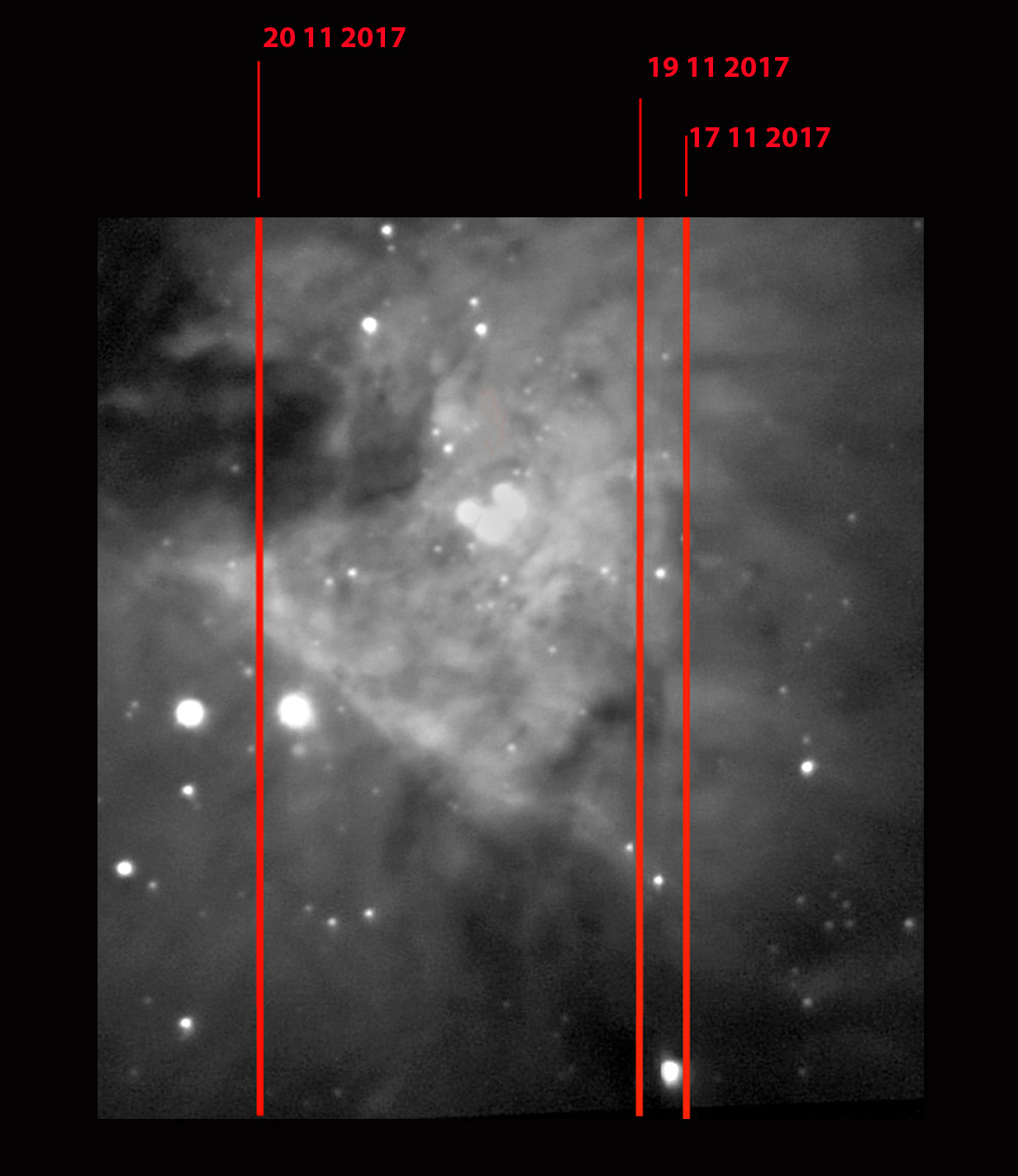
Si è posta attenzione a non fare inquinare gli spettri dalla
sovrapposizione di stelle di campo sulla fenditura, anche se una di esse ,
piuttosto debole, è apparsa ai margini dello spettro ed è stata comunque non
considerata nell’area di binning dello spettro bidimensionale per l’elaborazione
dei profili con Visual Spec.
Qui di seguito
i profili spettrali:
1-
quello del 17 novembre 2017
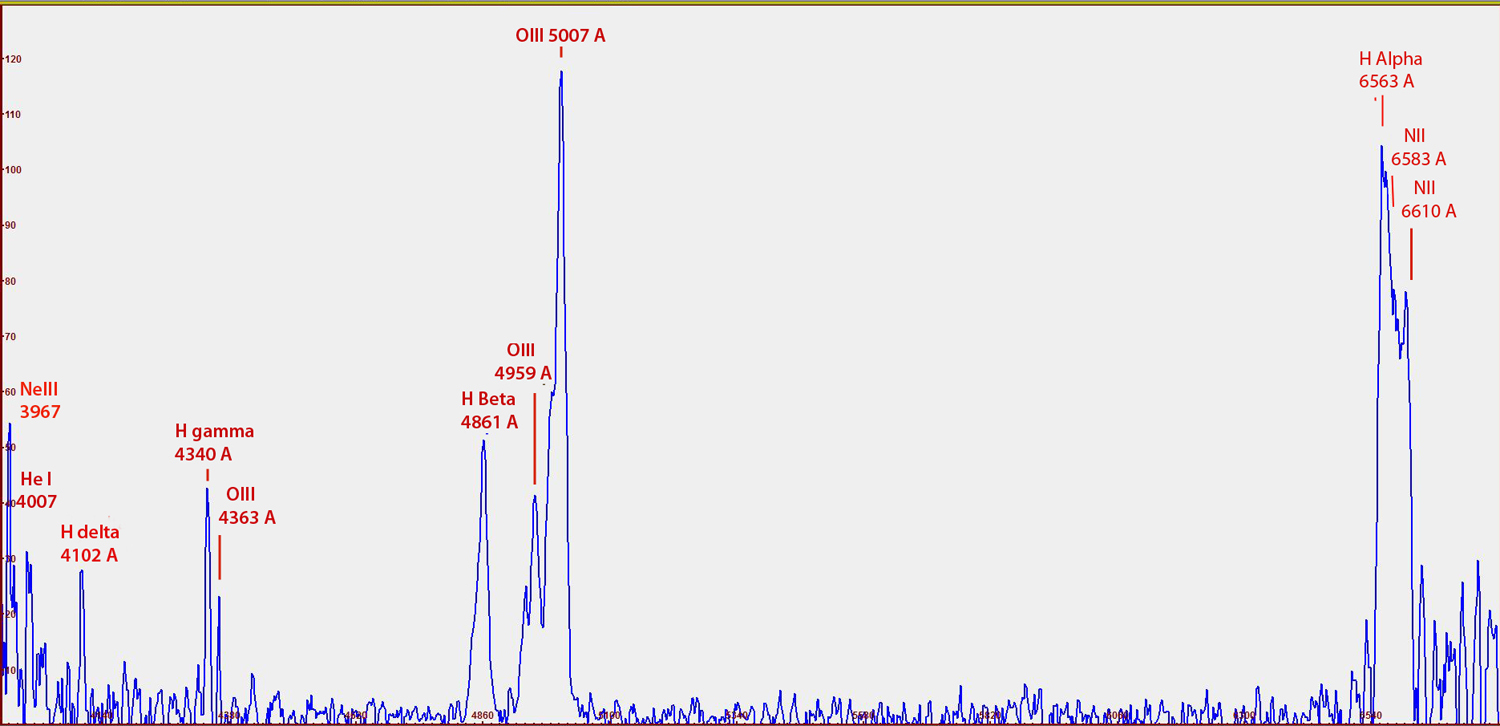
2-
quello del 19 novembre:
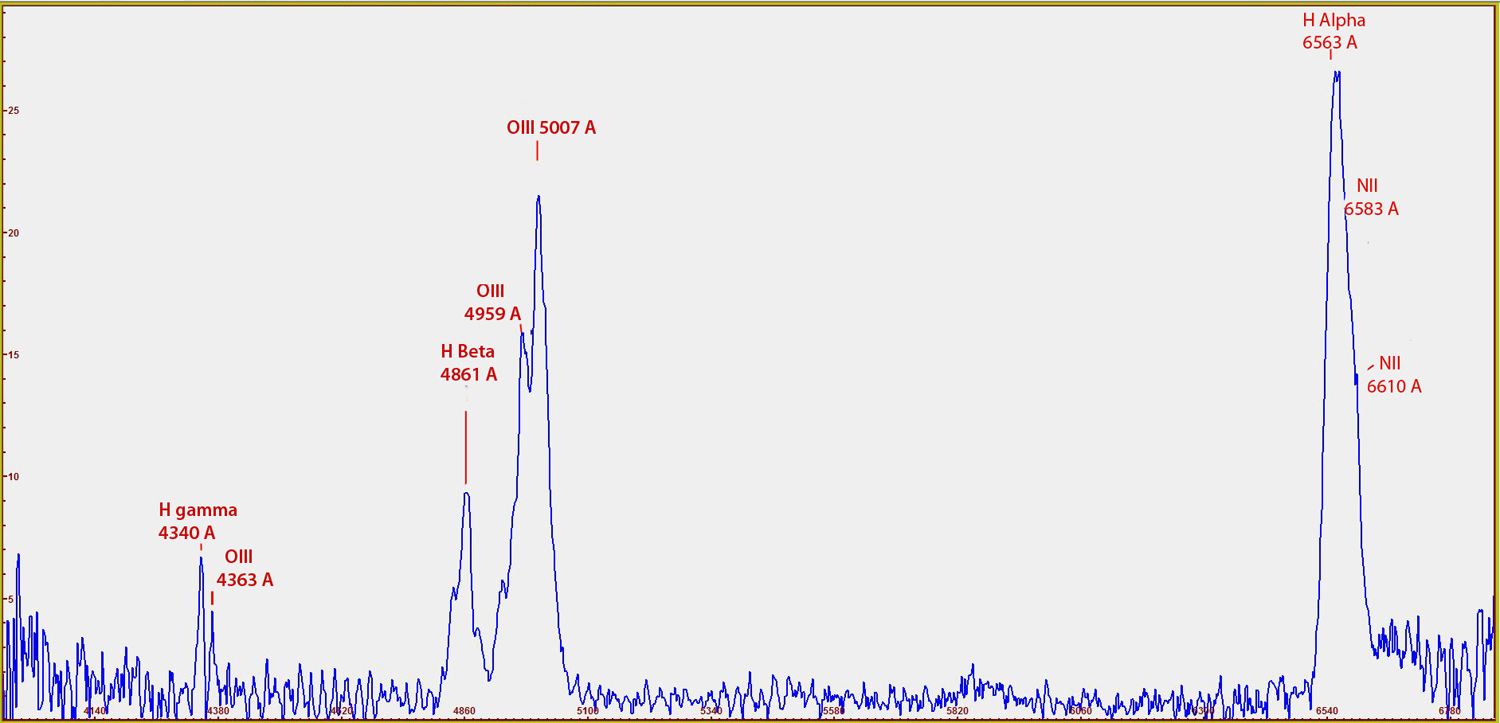
3-quello del 20 novembre:

Nelle immagini che seguono si è operata la
sovrapposizione della fenditura e quindi dei profili spettrali ottenuti
alle zone di
maggior interesse della nebulosa come risultanti dalle immagini del MUSE (fonte:
ESO - MUSE- Multi Unit Spectroscopic Explorer). Il MUSE è uno strumento di
seconda generazione applicato al fuoco Nasmyt del VLT, sul Cerro Paranal, in
Cile, uno spettrografo a largo campo nel visibile che si avvale dello
straordinario potere risolutivo del VLT.
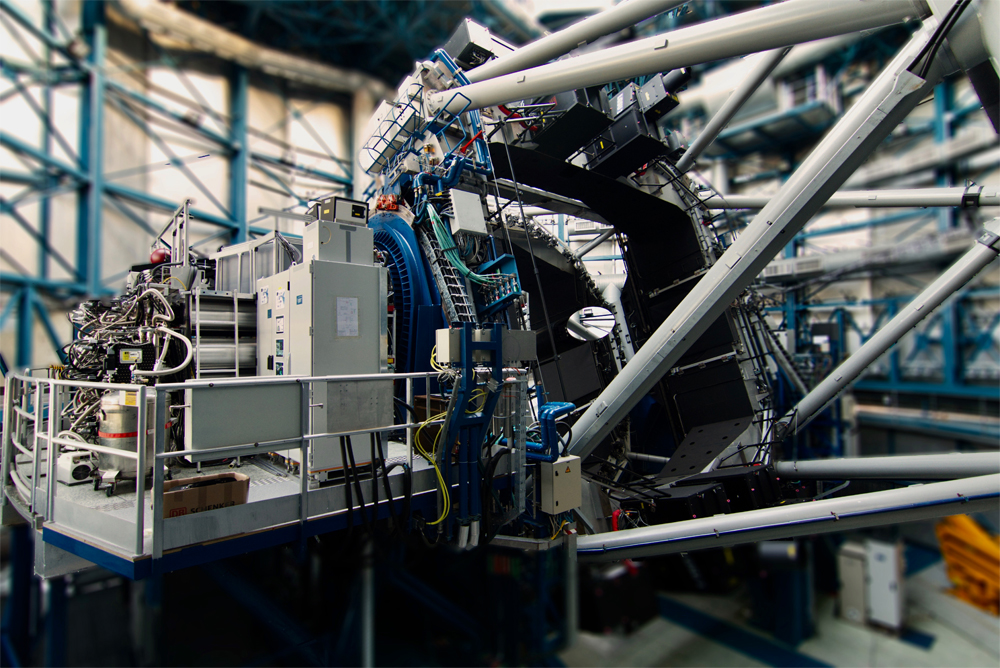
Lo spettrografo MUSE
![]()
La sovrapposizione, a titolo indicativo della posizione,
della fenditura sulla regione centrale di M42 notare la sovrapposizione del
primo spettro ad uno degli oggetti Herbig Haro,il più debole di quelli presenti
in M42 ed alla SW cloud.
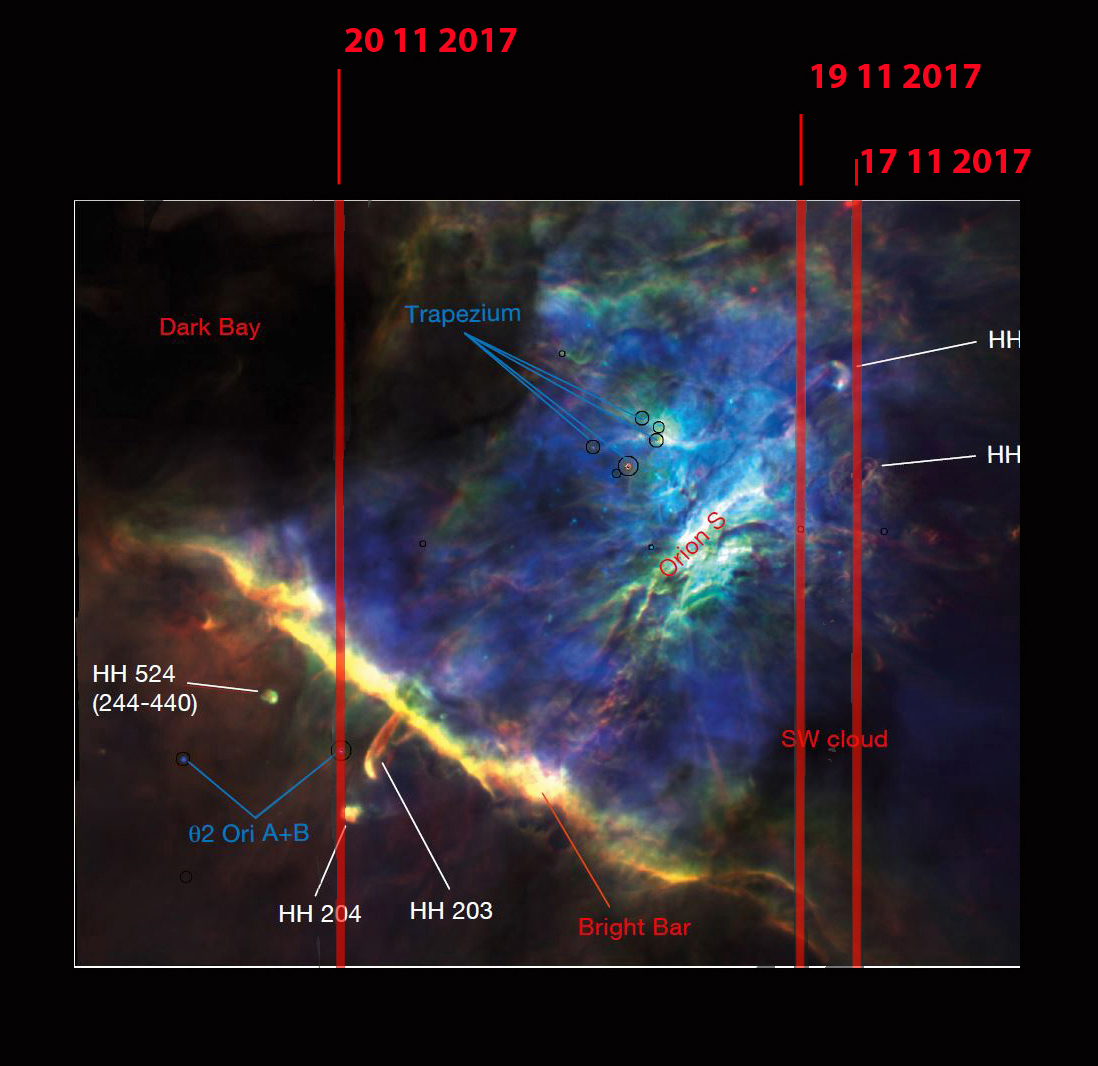
Nella figura sottostante,elaborazione di un immagine sempre
fonte ESO- MUSE, con la mappa del livello di estinzione della nebulosa derivante
dal rapporto Ha/Hb, si notano le posizioni approssimate della fenditura a AR 5h
35’ 10” ;5h 35’ 12”; 5H, 35’ 24.5”.Il livello di estinzione, derivante dal
rapporto Ha/Hb non è stato considerato nei dati che seguono,in quanto compreso
nell’errore di misura della strumentazione usata.
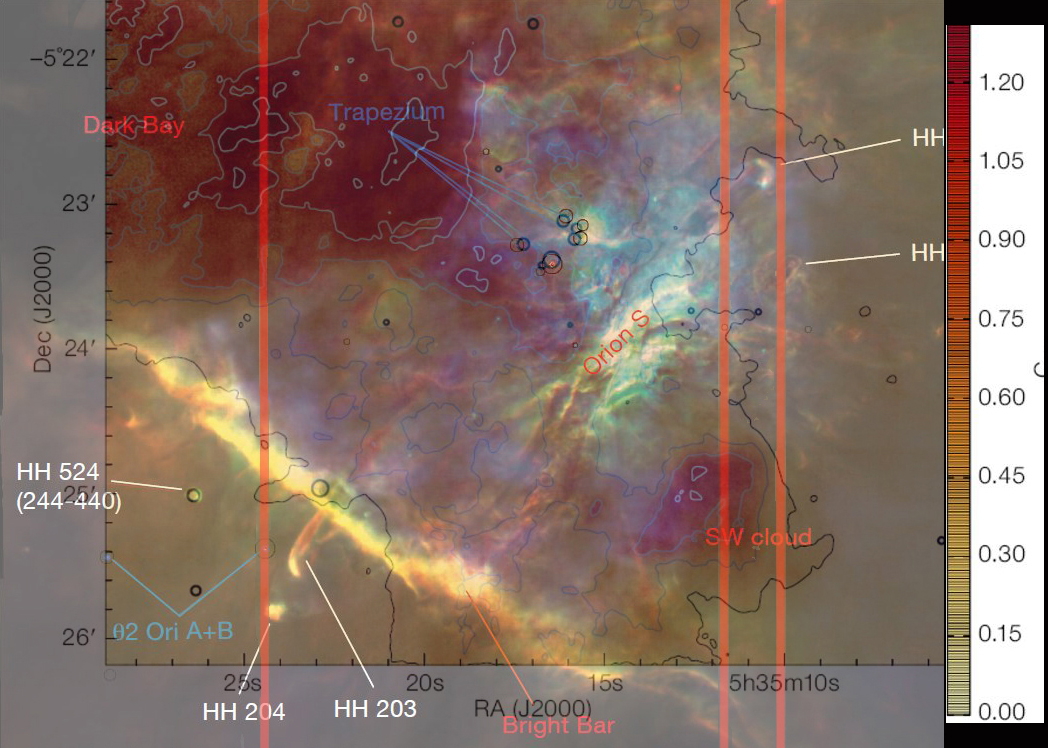
Il processo di ionizzazione
di M42
Il processo di ionizzazione di M42 è causato dalla forte
radiazione ultravioletta delle stelle del trapezio, e principalmente da Theta 1
Orionis C, la più luminosa dell’ammasso, classe spettrale O6: una stella di
temperatura superficiale di 40.000 K con venti solari da 1000 kms, ed anche una
binaria,con un compagno di classe B.
La struttura di ionizzazione della parte centrale della
nebulosa è chiaramente rappresentata nella seguente immagine del MUSE, ottenuta
dall’indicatore Hbeta/OIII 5007:altri rapporti vengono anche comunemente usati,
come quello OIII/Hbeta (inverso del precedente); NII/Halpha, etc.I valori della
tabella indicata nell’immagini sono stati depurati dell’estinzione.L’OIII resta
un indicatore di media ionizzazione, mentre l’N II di basso grado di
ionizzazione.
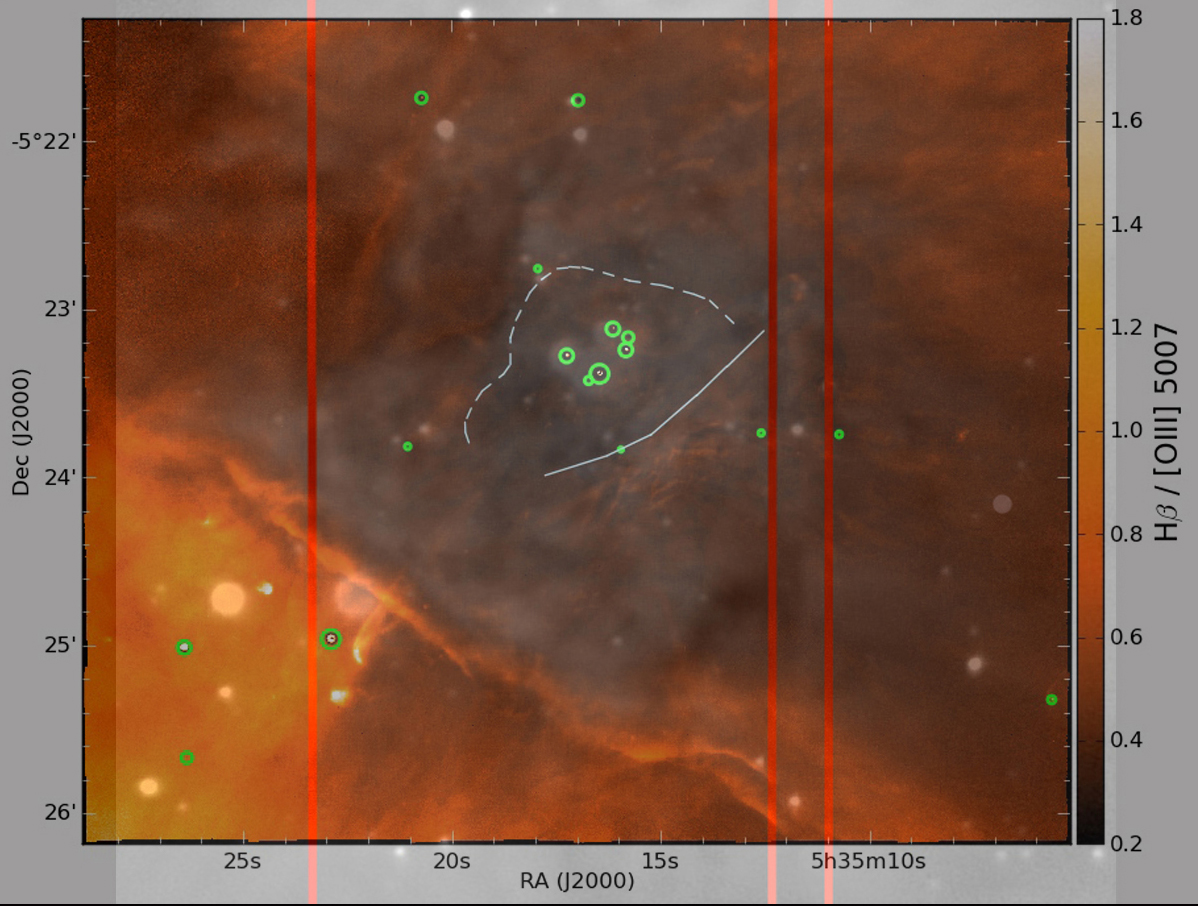
E’ stata effettuata, sui dati di intensità dei profili
non corretti per l’estinzione, la misura dei flussi delle righe H beta e OIII
nelle tre osservazioni per ottenere il predetto rapporto HBeta /OIII.Essendo le
righe esaminate in blend con altre righe, la determinazione dell’ampiezza di
riga
è risultata problematica né, d’altro canto, l’uso di un gaussian fit sull’intera
riga avrebbe potuto migliorare molto la situazione.Si è quindi calcolata
l’ampiezza sulla metà della riga non soggetta a blend ,e la si è moltiplicata
per due, con un margine di errore medio stimato sui 10 A per l’OIII 5007 e 2 A
per l’H beta.
Per ottenere il flusso di una riga occorre integrare il suo
profilo in direzione della lunghezza d’onda, tenendo conto che per la sua forma
una riga spettrale si può assimilare ad una gaussiana, con la seguente
approssimazione:
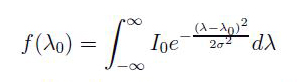
Dove
![]() è la lunghezza d’onda della riga
è la lunghezza d’onda della riga
![]() è l’intensità alla predetta lunghezza d'onda
è l’intensità alla predetta lunghezza d'onda
![]() è il parametro di ampiezza di riga
è il parametro di ampiezza di riga
Dalla precedente si ottiene la seguente, piuttosto semplice
da applicare:
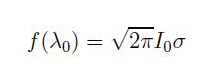
I valori ottenuti nei rapporti dei flussi H beta/OIII 5007
per i profili spettrali relativi ai i tre giorni di osservazione sono stati i
seguenti, poi riportati nell’elaborazione della precedente immagine del Muse.
17/11
135/192
=
0.70
+- 0. 13
19/11
65/111
=
0.58
+- 0.13
20/11
86/156
=
0.55
+- 0.13
L’elevato errore stimato, tra il 18 ed il 23% è in
massima parte dovuto al blend delle righe OIII 5007 – OIII 4959 ed alla
conseguente difficoltà di determinazione dell’ampiezza di riga, ragion per cui
avrebbe potuto essere molto più contenuto usando uno strumento di risoluzione
più elevata, che separasse nettamente le righe
con la medesima apertura di fenditura e/o lo stesso strumento con
una chiusura di fenditura raddoppiata (ca 15- 20 micron) a spesa tuttavia di un
rapporto S/R di gran lunga peggiore, a parità di apertura del telescopio e di
localizzazione del setup osservativo.
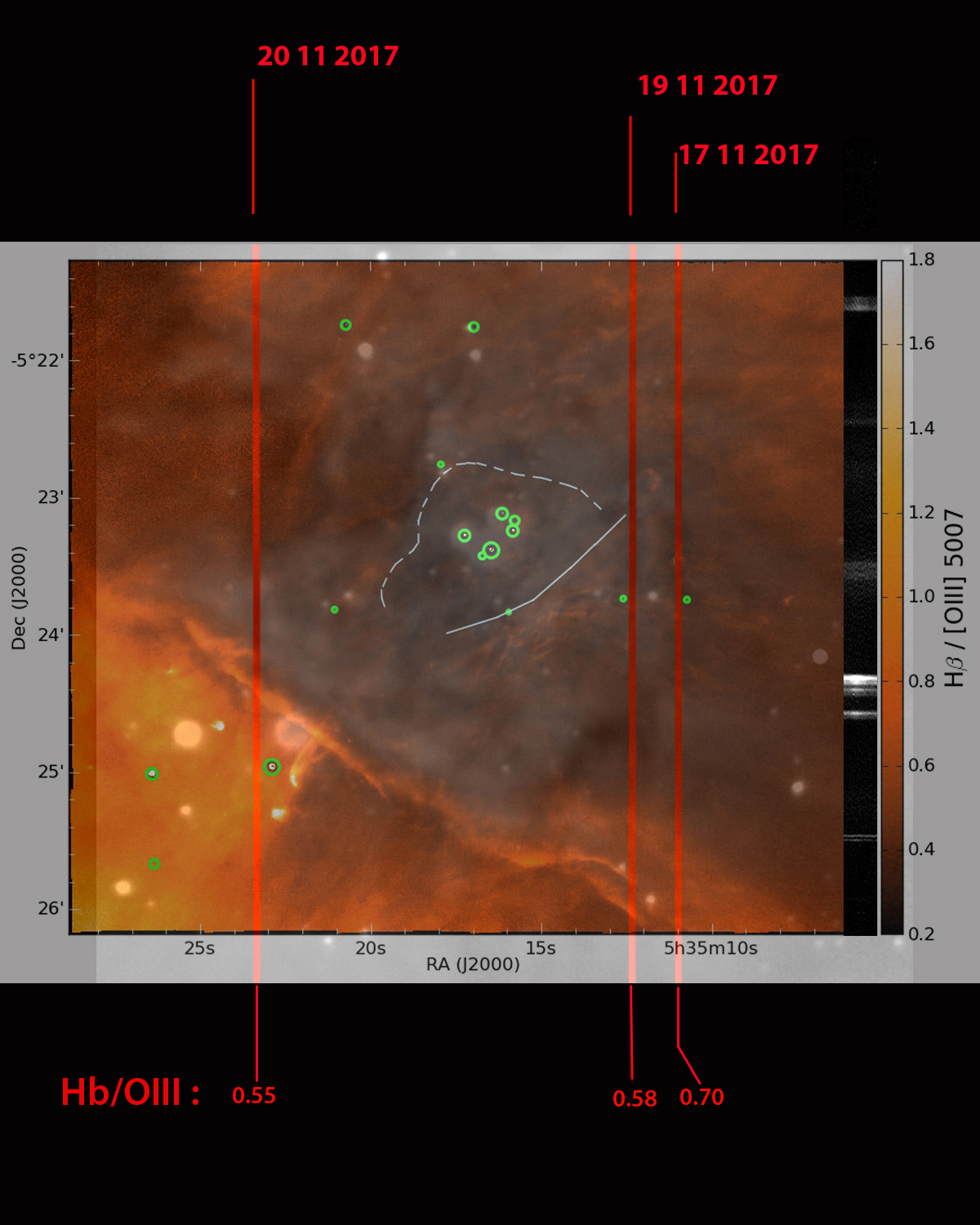
I valori ottenuti, a parte la questione dell’errore elevato,
sembrano sufficientemente coerenti, tenuto conto dell’astronomica (è proprio il
caso di dire) differenza nelle strumentazioni con quelli riportati nella mappa
ESO sulla struttura di ionizzazione della nebulosa.
![]()
Riferimenti:
ESO –VLT_MUSE
http://muse-vlt.eu/science/m42/
PPAK integral field spectroscopy of Orion Nebula (S.F Sanchez e al, 2007)
Università di Padova- Dipartimento di Fisica